Il quadro storico
L'Età Medievale

La pagina è in fase di sviluppo e pertanto forma e contenuti potrebbero non essere definitivi.

Se per la colonia romana di Julia Augusta Taurinorum le fonti consentono di confermare l’esistenza di una rete idraulica, senza tuttavia permetterne una descrizione dettagliata, per l'epoca medievale si può delineare un quadro d'insieme, ma rimane difficile tracciare una mappatura precisa e completa dei canali e delle bealere torinesi a causa della scarsità della documentazione e dell’assenza di una cartografia coeva. Centrale fu, in questo contesto, fu il ruolo della Bealeria Coleasche.
Ultimo aggiornamento: 07/01/2026
Contenuti
1. L'eredità romana
La colonia di Julia Augusta Taurinorum disponeva certamente di strutture idrauliche. L’agricoltura irrigua e la centuriazione delle campagne si avvalevano necessariamente di opere di captazione, regolazione, distribuzione e smaltimento delle acque, mentre filari di alberi, rogge e strade interpoderali delimitavano le proprietà. (Cfr. L'Età Romana) In città, la pulizia delle abitazioni e delle strade, le terme e le fontane pubbliche e private implicavano a loro volta l’approvvigionamento idrico, forse garantito da un acquedotto. Tuttavia, a fronte di un quadro generale verosimile, i ritrovamenti archeologici e le fonti scritte non consentono di aggiungere molto alla postulata esistenza di un tale sistema d'acque.
Declino e riorganizzazione del sistema idrico
Con la fine dell’Impero e il declino della colonia, questa rete idrica andò in rovina: le canalizzazioni si interrarono e le opere di regolazione e controllo caddero in disuso. Il collasso del sistema delle acque fu al tempo stesso conseguenza e moltiplicatore della crisi politica, economica e demografica altomedievale. Gli effetti su un paesaggio agrario in gran parte artificiale che richiedeva una costante cura per la sua conservazione furono disastrosi. Grandi superfici di terra fertile e coltivata vennero abbandonate, e arativi e vigne furono sostituiti dai boschi. I cedimenti degli argini dei corsi d'acqua, aggravati dalla maggiore piovosità e dalla fine dei lavori di mantenimento e regimentazione, furono all’origine della diffusione di paludi e acquitrini.
Continuità e recupero del territorio
Le tracce, ipotetiche, del rapporto tra il paesaggio romano e medievale si affidano alla conformazione del territorio e alla tendenza alla conservazione, a scala locale, dei tracciati di strade e canalizzazioni. Tuttavia, l’ipotesi di una continuità del quadro territoriale tra le due epoche è generalmente accettata. Si ritiene infatti che le distruzioni, la scomparsa degli insediamenti, l'arretramento delle pratiche agricole e il riaffermarsi della boscaglia, dell’incolto e delle paludi — avvenuti nei secoli bui della decadenza imperiale, delle invasioni barbariche e dell’alto Medioevo — compromisero, ma non cancellarono del tutto la precedente organizzazione delle campagne; e che i resti di cascinali e ville rustiche romane, gli alvei abbandonati e le strade, furono recuperati dall’opera di riorganizzazione successiva all’anno Mille, contribuendo alla ripresa dell'economia e al ritorno di un’agricoltura razionale.
Continuità delle reti idriche?
Il nesso tra le reti idriche romana e medievale è plausibile. Tale congettura pare rafforzata dal principio di inerzia del paesaggio agrario, secondo cui, una volta fissate, certe forme tendono a conservarsi anche quando vengono meno i rapporti e le condizioni tecniche, economiche e sociali che ne sono all'origine; perlomeno fino a quando nuovi e decisivi cambiamenti non le sconvolgano e le cancellino definitivamente. (1.1) Tale fenomeno trova una conferma nel caso torinese, dove lo sviluppo umano si è intrecciato con vincoli ecologici di natura geomorfologica e idrologica rimasti stringenti e invariati nel tempo. Nella fattispecie, il digradare regolare del piano da ovest verso est e la presenza di un fiume come la Dora Riparia, favorevole alla creazione e il deflusso di derivazioni artificiali ne costituiscono un esempio.
Questa persistenza è stata indagata da A. Cavallari Murat — ipotizzando che canali e bealere romani alimentati dalla Dora Riparia, con punti di presa e tracciati a noi noti, siano sopravvissuti dall’età medievale fino a tempi assai recenti — senza produrre esiti soddisfacenti. La ricerca è stata condotta sovrapponendo la maglia teorica delle centuriazioni alle carte topografiche dello Stato Maggiore dell’Esercito Piemontese del 1854 e alle odierne fotografie aeree. Il lavoro ha risentito sia dello stato delle conoscenze circa il reticolo idraulico delle due epoche, sia dei limiti delle tecniche e degli strumenti di indagine del tempo. (1.2) Sarebbe quindi interessante disporre dei risultati ottenibili con gli strumenti attuali delle ricerca territoriale, e in particolare del sistema informativo geografico (GIS). Recenti studi condotti da S. Caranzano sulla continuità dell’antica centuriazione romana nei disegni del territorio dei secoli successivi hanno prodotto risultati interlocutori ma incoraggianti. (1.3) In definitiva, l’attribuzione di un’origine romana — almeno in parte — al sistema idrico medievale è ipotizzabile su basi speculative o indiziarie, ma la mancanza di prove la riduce a semplice suggestione non dimostrabile in concreto.
note 1 __________________________________________
(1.1) Cfr. E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Ed. Laterza, Bari, 1961.
(1.2)Cfr. Forma urbana ed architettura nella Torino barocca: dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche, a cura di A. Cavallari Murat, Vol. I, Torino, UTET, 1968, p. 361-369.
(1.3) Cfr. S. Caranzano, La centuriazione di Augusta Taurinorum: “nuovi” dati dal territorio, Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Anno 156, n° 2-3 - dicembre 2023, pp. 9-17, e, dello stesso autore, Survey nella centuriazione di Augusta Taurinorum (Alpignano, Collegno, Druento, Pianezza, San Gillio), in “Ad Quintum – Archeologia del Nord-Ovest" n° 11 Gennaio 2022 (anno LI), pp. 52-117.
Sulle fonti, sul metodo e sui risultati
Tra assenza di fonti e prime menzioni
«Non v'è dubbio che lo studio dei secoli anteriori al Trecento presenti a Torino una particolare difficoltà, poiché alla scomparsa delle testimonianze materiali si accompagna la mancanza delle ricche serie documentarie dei secoli successivi». L'osservazione risulta ancor più calzante per un tema specialistico come quello delle derivazioni idrauliche, per il quale le fonti risultano particolarmente parche. (a) Le prime menzioni relative a questioni d’acqua provengono dai cartari delle grandi istituzioni religiose e riguardano la compravendita o l'accensamento di mulini e gualchiere (b). Tali atti, tuttavia, si limitano ad attestare la concessione di impianti — spesso collocati direttamente sui fiumi o a breve distanza — e riportano solo rari riferimenti alle canalizzazioni che li alimentavano. (Cfr. I molini di Dora) Anche le sporadiche e fugaci menzioni di generici elementi idraulici dei primi due secoli dell'era volgare non consentono di formulare ipotesi sul sistema idraulico torinese nel periodo in cui esso ha avuto origine, lasciando il quadro delle conoscenze sostanzialmente ignoto.
Sfide e implicazioni della documentazione
La documentazione diventa più ricca a partire dal Trecento, secolo su cui si focalizza questa ricerca. Gli Ordinati, ossia i verbali delle sedute degli organi collegiali del Comune, forniscono informazioni regolari sulla vita economica, politica e sociale cittadina a partire dal 1325. Sebbene incomplete, (c) queste serie risultano fondamentali per lo studio della gestione del territorio e delle acque. Informazioni di natura topografica, sono ricavabili inoltre da un discreto corpus di atti notarili e, dal 1349, dai Consegnamenti di case e beni (ovvero dagli estimi catastali), utili soprattutto per le notizie desumibili dai confini delle proprietà.
La debolezza e i problemi di interpretazione tipici delle fonti medievali hanno condizionato i risultati della ricerca. Le difficoltà sono derivate dall'incompletezza nella stesura degli atti, dal loro reperimento e da problemi di leggibilità e conservazione dei materiali. Anomalie, errori, omissioni e variazioni linguistiche, dovute anche alle peculiarità espressive dei singoli redattori, sono state frequenti; così come le imprecisioni grammaticali e sintattiche e l’abbondanza di espressioni idiomatiche — talvolta umoristiche e in forme sincretiche latino-dialettali — di non facile interpretazione. Molti nomi di persone e luoghi, comuni all'epoca, sono andati perduti, complicando identificazioni e collocazioni. Anche il potenziale euristico della toponomastica, pur rimanendo una risorsa preziosa per la ricomposizione territoriale, non ha sempre prodotto i risultati attesi.
Una riflessione generale riguarda le aspettative e l'approccio del ricercatore, in particolare il suo desiderio — a volte quasi "disperato", data la scarsità di dati — di attribuire un senso e una collocazione a ogni singola, pur minima e incerta, tessera del mosaico. Tale approccio, tipico del mondo odierno in cui ogni cosa è codificata e definita nel dettaglio, si è scontrato con la realtà di un’epoca in cui le conoscenze comuni e condivise non richiedevano troppo rigore nell’uso e nella registrazione di toponimi e antroponimi, e le varianti non suscitavano né problemi né sorpresa.
Questioni di documentazione e toponomastica
A queste problematiche non è sfuggita l'attribuzione degli idronimi. La complessità ha riguardato in primis le canalizzazioni minori e le rogge irrigue, in genere associate in modo sbrigativo ai nomi dei proprietari dei fondi, ma neanche quelle principali ne sono state esenti. La toponomastica di canali e bealere, non solo in epoca medievale, non è sempre univoca: i loro nomi talora si confondono o si sovrappongono, e gli errori topografici — come l'estensione del nome di una parte al tutto — sono piuttosto frequenti. Ancora una volta, la ricerca di coerenza e precisione assoluta — disattesa a volte persino nel singolo documento — appare una necessità classificatoria odierna più che un'esigenza dello spirito, dei metodi e degli strumenti della burocrazia medievale.
Si noti che, nonostante il ruolo economico e la rilevanza per la visione collettiva del territorio, le bealere non rientravano tra gli elementi di prestigio e i simboli del potere. È dunque plausibile che gli scavi e le aperture siano avvenuti informalmente, senza intitolazioni, celebrazioni o particolari cerimonie. E di conseguenza, che i loro nomi si siano formati lentamente in virtù di relazioni e consuetudini delle comunità, a partire da quelli dei finanziatori, delle località di presa, o di altri elementi, tramandandosi poi per tradizione orale, con le inevitabili incertezze e fraintendimenti.
Anche in epoche più recenti, nelle campagne, e dove le relazioni si esaurivano in aree circoscritte, troppe precisazioni erano superflue: in una certa parte del contado, ad esempio, 'la "bealera", o il "ponte” erano quelli noti a tutti e non richiedevano altre specificazioni. Anche negli Ordinati, questi termini possono comparire senza alcun nome associato, suggerendo che fossero riferiti a opere di rilievo, menzionate, quindi, in modo solo apparentemente generico. Infine, la poca dimestichezza con le specificità del territorio degli scrivani e della burocrazia municipale non hanno aiutato le interpretazioni.
In questo contesto, lo studio delle canalizzazioni torinesi di epoca medievale consente di delineare un disegno complessivo della rete idraulica, attendibile nelle sue linee generali, ma non una mappatura precisa di ogni tracciato.
Un'inferenza cartografica
La cartografia è uno strumento indispensabile dell'analisi territoriale; tuttavia, di "geografia" nel senso pieno del termine — cioè come "scrittura" e rigorosa descrizione della terra — si può parlare solo a partire dalla Rivoluzione scientifica del XVII secolo. Per il territorio torinese, purtroppo, non disponiamo di mappature anteriori a tale epoca. La più antica rappresentazione a noi nota — che costituisce anche la prima della rete idraulica — è il «Tipo dimostrativo del corso delle acque, che si derivano dalla Dora per la ficca Pellerina, si diramano per le vie di Torino, tra i limiti della strada di Grugliasco, i terreni del Valentino, la bealera di Vanchiglia, ed il ponte del parco sulla Dora» riportato nella fig. 2.3.
Tracciato da una mano anonima e attribuito alla prima metà del Seicento, il disegno è successivo di circa tre secoli al periodo considerato. Tuttavia, la naturale persistenza di elementi come strade e bealere e la generale lentezza della transizione dal paesaggio medievale a quello successivo, rendono ragionevole utilizzarlo per inferire il quadro trecentesco e colmare, almeno in parte, il vuoto della cartografia. Certamente, un metodo di indagine che utilizza fonti successive per ricostruire un periodo precedente non è privo di rischi. Nell'arco di tre secoli la società e l'economia possono aver subito cambiamenti così profondi da alterare significativamente il territorio. Si pensi, ad esempio, all’evoluzione delle coltivazioni e delle tecniche agrarie, e ai mutamenti delle dimensioni, dei confini dei fondi, nonché — nella fattispecie — alle trasformazioni urbanistiche di una Torino che si apprestava a diventare capitale. Questi effetti sono in larga parte “incontrollabili”, poiché la documentazione rende difficile stabilire con certezza cosa sia effettivamente cambiato e in che modo. La liceità di una simile proiezione retroattiva è tuttavia confortata dai buoni esiti ottenuti in passato. (d)
Nella mappa è evidente una rappresentazione simbolica di tipo medievale, basata su un linguaggio figurativo convenzionale e qualitativo più che su criteri metrici o proporzionali. A un primo sguardo, tali alterazioni possono farla apparire inattendibile: l’ampiezza della bealera principale, ad esempio, non è proporzionata rispetto alla Dora, e la superficie della sola Cittadella appare quasi pari a quella dell’intero abitato. Ignoriamo in quale misura l’autore possedesse nozioni di matematica e di cartografia scientifica, e se i criteri di equivalenza ed equidistanza gli fossero noti. Non sappiamo nemmeno se le distorsioni fossero intenzionali o per lui irrilevanti, né se l’intento fosse topografico o, più probabilmente, amministrativo. Tali osservazioni, però, non devono trarre in inganno: pur non consentendo di ricavare misure di superfici o di distanza, la lettura del territorio che ne emerge risulta coerente sia con le informazioni d'archivio, sia con le più affidabili mappature dei secoli successivi, e costituisce pertanto una base di lavoro accettabile.

Fig. 2.3 Il “Tipo dimostrativo del corso delle acque, che si derivano dalla Dora per la ficca Pellerina, si diramano per le vie di Torino, tra i limiti della strada di Grugliasco, i terreni del Valentino, la bealera di Vanchiglia, ed il ponte del parco sulla Dora” non è datato: è registrato nel 1648, ma restituisce lo stato del territorio, della città quadrata, della prima fortificazione moderna, delle attività produttive, della viabilità e del corso delle bealere antecedete di circa una ventina d'anni. Le canalizzazioni di probabile origine medievale sono evidenziate in turchese e le strade in marrone. La mappa conserva inoltre traccia di percorsi viari ormai abbandonati, che rappresentano un ulteriore motivo di interesse. Il disegno delinea una Torino in piena trasformazione. Sotto la dominazione francese, i borghi extraurbani medievali sono stati abbattuti, mentre insieme alla Cittadella imponenti bastioni — il Bastione di Santa Margherita, il Bastion Verde e il Bastion 'dilla Madonà — completano ora le difese di origine romano-medievale. A sud-ovest, la Cittadella domina il panorama, resa ancor più imponente dalle dimensioni vistosamente fuori scala. A sud sono abbozzati i primi isolati della "Città nova" lungo l’asse della via Nuova (l’attuale via Roma) deliberata nel 1620, ma non ancora piazza San Carlo, ancora privi di difese. Dalle porte cittadine si dipartono i grandi assi viari extraurbani, e dalla Porta Segusina, in particolare, le strade di Collegno e di Rivoli. Il territorio ha preso il nome di "Valdoco", toponimo che ha sostituito quello medievale di “Colleasca”, ed è costellato da cascine dai nomi oggi dimenticati. Non mancano infine elementi della geografia manifatturiera, come l'affaiteria e la sabbionera di Porta Palazzo e le fornaci di Valdocco.
La mappatura riguarda però principalmente la rete idraulica. Gli elementi di origine medievale sono facilmente riconoscibili, a partire dalla “ficca Pellerina”, con il suo “assoratore” (scaricatore). Il canale principale, pur non nominato, è la “bealera del Martinetto”, idronimo destinato a sostituire gradualmente il più antico di “bealera Colleasca”. Lungo il tracciato si notano il "martinetto da ferro" e il "molino del Martinetto", che stanno contribuendo al cambio di denominazione. A una distanza dalla città maggiore di quanto ipotizzato per il Trecento, ha origine la bealera del Fossato lungo, che si dirige verso il Po biforcandosi. Il ramo destro raggiunge i prati del Valentino, mentre il sinistro interferisce vistosamente con l’espansione urbana in atto. Il "canale della Porta Segusina" convoglia l'acqua in città attraverso un ponte canale gettato sul fossato delle fortificazioni. I molini della Città sono alimentati da una canalizzazione autonoma, derivata dalla Dora poco più a monte. Ma ciò che forse maggiormente risalta è la fitta rete di rogge e fossi che copre capillarmente le campagne, a testimonianza dell’importanza e dell’estensione assunte dalle irrigazioni. Altre canalizzazioni sono più recenti, come la “bealera dei Gesuiti” (in seguito nota come “bealera di S. Salvario e dei Borghesi”) e la "bealera nuova" che scorre a ridosso della cortina meridionale, fatta scavare da Carlo Emanuele I a vantaggio dei nuovi quartieri, sottraendo acqua alla città murata. Significativa è la traccia di una “rozza di S.M.”, che rimanda al canale del giardino reale (o meglio ducale) di Emanuele Filiberto. Un accenno così labile potrebbe giustificarsi con la committenza del disegno, e persino suggerirla, qualora fosse riconducibile alla Città di Torino, poco interessata a una canalizzazione del sovrano. L’epoca delle due bealere che si dipartono dalla Porta Segusina è incerta. La prima scorre nel fossato e funge da canale scaricatore per l’acqua che entra nell’abitato e, raccolti gli scoli urbani, termina nella "bealera di Vanchiglia", collettore generale degli scarichi urbani. La seconda, che sembra prolungare la bealera principale, scende verso Porta Palazzo, convergendo in parte nella “bealera dei Molini” e in parte in quella di Vanchiglia. I molini di Porta Palazzo sono mossi da una bealera propria derivata da una ficca collocata sulla Dora parecchio dopo quella della Pellerina.
Fonte: ASCT, CS 1977
note __________________________________________
(a) Cfr. A. Benedetto e M.T. Bonardi, Lo sviluppo urbano di Torino medievale, in "Paesaggi urbani dell’Italia padana nei secoli VIII-XIV", Bologna, Cappelli Editore, 1988, p 129. — Per un quadro dettagliato dell'economia torinese del Duecento, cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, in G. Sergi (a cura di), Storia di Torino Einaudi, Vol. I , Torino, 1997, pag. 751 e segg.
(b) Le gualchiere, con la battitura meccanica dei panni-lana da cui si ottenevano feltri compatti ed impermeabili, erano parte di un ciclo produttivo basato sul lavoro a domicilio. Come quasi ovunque in epoca medievale, le produzioni tessili laniere rappresentavano la principale attività manifatturiera.
(c) La lettura degli Ordinati dei primi secoli, denominati Libri Consiliorum, richiede conoscenze paleografiche specialistiche. Fortunatamente, per quanto riguarda una larga parte del Trecento, l’Archivio Storico della Città di Torino ne ha pubblicata la trascrizione, rendendoli decisamente più accessibili. La raccolta non comprende soltanto i verbali delle sedute degli organi collegiali del Comune (Maggior Credenza, Minor Credenza, commissioni di sapientes con incarichi speciali…) ma anche documenti di altra natura che arricchiscono la mole delle informazioni disponibili. Tuttavia, la serie archivistica non è completa, poiché mancano i volumi di ventisette annate. Pertanto, sono effettivamente disponibili le seguenti scansioni temporali:
- Libri Consiliorum, I, 1325-1329
- Libri Consiliorum, II, 1333-1339
- Libri Consiliorum, III, 1342-1349
- Libri Consiliorum, IV, 1351-1353
- Libri Consiliorum, V, 1365-1369
- Libri Consiliorum, VI, 1372-1373
- Libri Consiliorum, VII, 1376-1379
- Libri Consiliorum, VIII, 1380-1383
- Libri Consiliorum, IX, 1384-13865
- Libri Consiliorum, X, 1387-1389
- Libri Consiliorum, XI, 1390-1392
(d) Cfr. A. Benedetto e M.T. Bonardi, Lo sviluppo urbano di Torino medievale, cit. — Confrontata con i Catasti trecenteschi e quattrocenteschi, la carta di Torino di Joan Carracha del 1572 — utilizzata dalla ricerca e anteriore disegno in questione soltanto per qualche decina d'anni — si è dimostrata un valido strumento per definire l'impianto urbanistico cittadino dei tre secoli precedenti.
2. Il quadro medievale
In Europa, lo sfruttamento dell’energia idraulica si diffuse lentamente a partire dall’Alto Medioevo. Fin dal VI secolo, la regola di San Benedetto considerava aquae et molendina essenziali per l’autonomia delle abbazie. Spesso furono proprio gli ordini monastici, soprattutto dopo l'anno Mille, a sviluppare i sistemi irrigui e ampliare gli spazi di un’agricoltura fino ad allora confinata vicino alle città. La diffusione della rete idrica accompagnò l’espansione delle superfici coltivate, in particolare del prato irriguo e dell’allevamento del bestiame, tipici della riconversione agricola del basso Medioevo. (2.1)
Prati e bealere tra Tre e Quattrocento
Concluso il lungo ciclo di espansione agricola del Duecento, il crollo demografico provocato dalle pestilenze del secolo successivo determinò nuovi e profondi mutamenti nei regimi alimentari e nell’uso e nella destinazione dei terreni nelle campagne. Superati i momenti più critici, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, si assistette a una significativa espansione delle aree prative a scapito della cerealicoltura. La terra divenne meno scarsa in relazione ai bisogni della popolazione, e il calo della domanda portò all'abbandono delle terre marginali e meno produttive che in precedenza erano messe a coltura per sostenere un maggior numero di abitanti. Con meno bocche da sfamare, fu possibile destinare più terra al pascolo e all'allevamento del bestiame. La scarsità di manodopera determinò un miglioramento dei salari, che permise a più persone di accedere a cibi di miglior qualità e più vari, come carne, latte e formaggi, e in generale a un'alimentazione più varia e ricca. In questo contesto, l'irrigazione divenne un fattore chiave per la produzione e per la produttività del foraggio, poiché consentiva tre sfalci di fieno all’anno (a maggio, agosto e ottobre) rispetto agli uno o due dei prati asciutti. (a)
Nelle campagne torinesi
Questi fenomeni trovarono riscontro anche nelle campagne torinesi, dove si ebbero un diffuso spopolamento e una marcata contrazione delle aree coltivate, a partire da quelle di maggiori dimensioni e da quelle marginali. È altresì documentata la conversione a prato irriguo, che portò quasi al raddoppio delle superfici e al netto miglioramento della produzione di foraggi, accompagnato dallo sviluppo delle coltivazioni miste (alteno) e di quelle specializzate, come la vite. La disponibilità di foraggi favorì la diffusione dell’allevamento, orientato verso suini e ovini per i consumi alimentari, mentre ai bovini erano riservati i lavori agricoli e le attività di trasporto.
La crescita della superficie prativa non rappresentò un semplice mutamento colturale, ma contribuì ad attivare circoli virtuosi all'interno del sistema agrario. L’irrigazione consentiva, infatti, più tagli di erba e un impiego più intenso dei buoi, con un duplice effetto migliorativo: da un lato una maggiore disponibilità di concime, dall’altro una superiore capacità arativa. Al tempo stesso, i bovini — grandi consumatori di foraggio — richiesero superfici prative sempre più estese, rendendo necessario, e al tempo stesso sostenibile, e quindi lo scavo di nuove canalizzazioni.
Alla del periodo il processo di ristrutturazione e ricolonizzazione agraria appariva ormai concluso: le irrigazioni erano ormai diffuse in modo capillare, mentre le giornate di terra irrigua, il numero degli utilizzatori e delle proprietà raggiunte erano aumentati in misura considerevole, e il sistema idrico risultava sostanzialmente strutturato. Tali dinamiche apparivano irreversibili e ponevano le campagne in condizione di affrontare con maggiore resilienza le situazioni di crisi, senza che queste interrompessero i processi avviati.
note __________________________________________
(a) Cfr. A. Fiore, A. Poloni, L’economia medievale. Un profilo storico (secoli V-XV), Carocci Ed., Roma, 2024.
Due grandi bealere torinesi...
La Dora Riparia è considerata il fiume torinese per eccellenza. In epoca medievale dava origine alle due canalizzazioni che costituivano gli assi portanti del sistema idrico cittadino:
-
La bealeria Colleasche, spesso definita "magna", era la principale. Traeva origine dalla ficha Pellerine, lo sbarramento collocato ai confini metropolitani occidentali, e risaliva il terrazzo fluviale fino all'abitato. Ad essa erano collegate il canalis Portam Secusinam, che introduceva l'acqua all'interno dell'abitato, e il Fossatum longum, che costeggiava le mura a sud, sfociando nel Po. Da queste canalizzazioni si diramava una fitta rete di rogge e fossi che irrigavano le campagne verso Vanchiglia, il Valentino, S. Salvario e la Crocetta.
-
La bealerìa Molendinorum alimentava i mulini da grano e gli opifici situati fuori Porta Palazzo. Derivava dalla ficha molendinorum, eretta anch'essa sulla Dora, sebbene più a valle rispetto alla precedente, oggi nell’area di piazza Baldissera e del Fortino. Scorrendo prossima e parallela al fiume, dopo l’uso terminava nei prati di Vanchiglia. A partire dalla seconda metà del XV secolo, lungo una sua derivazione secondaria si insediarono le macchine idrauliche — ressie, molere, peste e battitoi — di quel nucleo protoindustriale destinato a svilupparsi nei secoli successivi attorno ai mulini.

Fig. 2.1 — Tracciati delle due principali canalizzazioni torinesi di epoca medievale: la Bealeria Coleasche e la Bealeria Molendinorum. (Il disegno è provvisorio, il corso della Dora risale alla fine del XV secolo, i tracciati di canali e strade sono semplificati e solo indicativi.
... e il restante sistema irriguo medievale
Nelle campagne, le acque delle bealere erano impiegate anche nei lavatoi e per le tradizionali funzioni rurali, come la pulizia delle stalle e l’abbeverata del bestiame, mentre l'uso domestico diretto era assai raro. In Torino contribuivano alla pulizia delle strade e alla bagnatura di orti e giardini e, fuori le mura, di prati e canaperie. Soprattutto a partire dal Quattrocento, furono sfruttate anche come fonte di energia per gli "ingegni" dediti alle lavorazioni manifatturiere.
L'uso alle acque del Po, della Stura e del Sangone era limitato dalla maggior distanza dalla città. I molini di Sassi, di proprietà dei canonici del Duomo, sono attestati fin dal 1047 e, sempre in epoca medievale, si ha notizia di un mulino degli Zucca e di un batenderium Cabureti, operanti entrambi sul fiume. Dal 1115, il monastero di San Solutore Maggiore beneficiava, per concessione vescovile, dei diritti di pesca e della facoltà di costruire mulini sul Po, da Testona alla confluenza con la Stura. (2.2)
Questi impianti non provvedevano tanto alle necessità della popolazione torinese, quanto piuttosto a quelle degli insediamenti sulla sponda destra del fiume, i quali, pur sotto la giurisdizione di Torino, godevano di autonomia e vita propria. I mulini fluviali erano ‘natanti’, cioè montati su pontoni, soluzione dovuta, sia alla possibilità di derivazione del fiume, sia per non ostacolare il passaggio delle barche.
Sebbene in epoca medievale la navigazione commerciale sul Po avesse una certa rilevanza, non ne sono rimaste tracce evidenti; le vie di comunicazione che interessavano Torino erano, in ogni caso, prevalentemente terrestri. (2.3) Anche le menzioni di portus, naves e naute si riferivano a semplici traghetti, anziché a veri approdi mercantili. (2.4) Questo tipo di attraversamenti erano diffusi su tutti i fiumi: ricorrenti sono, ad esempio, quelli di San Vito (sul Po) e di San Giacomo di Stura, oltre ovviamente a quelli sulla Dora.
Sovranità e gestione delle acque
La sovranità sulle acque era subordinata all’autorità dei Savoia — si vedano, ad esempio, le patenti del conte Amedeo VI (1360), del principe d’Acaja (1410) e del duca Ludovico (1454) — mentre l’apertura di nuove canalizzazioni era demandata a signori feudali, istituzioni monastico-religiose, consorzi di comunità locali o gruppi di medio-grandi proprietari riuniti per l’occasione, ossia a soggetti dotati delle capacità tecniche e finanziarie necessarie. (2.5)
Le bealere derivate dalla Dora in grado di irrigare le terre sul pianalto richiedevano interventi onerosi: la palizzata-diga di sfioro, i canali scaricatori come misura di sicurezza contro le piene, la chiusa d’imbocco e lo scavo di lunghi tratti d’alveo — talvolta in condizioni difficili, in galleria o muniti di opere di sostegno in legno o muratura. A ciò si aggiungevano l’acquisto dei terreni necessari e i permessi di passaggio nelle proprietà attraversate.
A fronte dei cospicui capitali investiti, le nuove opere idrauliche risultavano assai redditizie, purché il contesto socioeconomico consentisse pratiche agricole remunerative, come indicano gli aumenti dei fitti dei prati irrigui e delle ore d’acqua nel corso del Quattrocento. (2.6) (Cfr. scheda)
Alle origini del sistema idraulico extraurbano
Almeno dal XIII secolo i cartari vescovili e monastici documentano l’esistenza di canalizzazioni artificiali nell’area pedemontana torinese, in particolare nelle terre dell’abbazia di San Giacomo di Stura e nella zona di Settimo, irrigate dalla Stura di Lanzo. Per l’area attraversata dalla Dora Riparia le informazioni risultano invece meno circostanziate.
Dopo le positive dinamiche di crescita del Duecento, in linea con le tendenze generali del periodo, dalla seconda metà del secolo successivo la campagna torinese attraversa una fase di ristagno. Il calo demografico e le difficoltà provocate dalle ricorrenti ondate di pestilenza portano all’abbandono o all’uso estensivo delle terre, cosicché ampie aree rimangono incolte o destinate a usi comunitari, pascolo e bosco. Le grandi proprietà fondiarie, laiche ed ecclesiastiche, appaiono frammentate e non pienamente valorizzate, mentre le comunità rurali dispongono di margini ridotti per sostenere innovazioni e nuovi investimenti. (2.7)
Cronologia delle bealere
del circondario
Fig. 2.2 — Le date indicate sono ricavate dai titoli presentati dai consorzi di gestione alla Commissione Pernigotti nel 1840. Tali documenti potrebbero tuttavia celare una origine precedente, o attribuire una costruzione ex-novo a prolungamenti o rifaci-menti di opere preesistenti, ed è quindi possibile che alcune derivazioni siano anteriori agli anni qui riportati.
Tali condizioni di arretratezza, che perdurano fino alla prima metà del Quattrocento, si riflettono in un sistema irriguo debole e frammentato. Sebbene la sua antica presenza sia più che plausibile, le attestazioni documentarie risultano labili e sporadiche, spesso ricavabili solo da riferimenti indiretti. Con l’eccezione della bealera Colleasca, di probabile origine duecentesca, le derivazioni esistenti — forse ottenute dalle divagazioni secondarie dei fiumi tramite opere di presa semplici e talvolta posticce — rimangono limitate alle fasce più prossime agli alvei, le cosiddette "basse", e circoscritte al territorio comunale. A queste si aggiungono modesti corsi d'acqua detti rivi (rivum nelle fonti), generati da fontanili, ossia polle o sorgenti naturali affioranti non lontano dalle sponde. Le conoscenze si ampliano con le dichiarazioni catastali trecentesche, le quali sebbene i non consentano molto più della semplice attestazione di esistenza dei corsi d'acqua, confermano la crescita delle superfici irrigue lungo tutto il periodo, pur generalmente ancora in assenza di derivazioni di rilievo per lunghezza e portata.
Nel Trecento...
Lo spazio torinese di epoca medievale meglio documentato è l’Oltredora, ossia il territorio a nord della Dora Riparia, ampiamente analizzato dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino. (2.8) Qui, fin dai Consegnamenti del 1363 si segnala la presenza di prati irrigui nella regione di confluenza della Stura e della Dora nel Po, dove la conformazione delle sponde facilitava l’adduzione delle acque. Nella zona di Burrono — nelle basse di Stura presso la confluenza — un rivum irrigava svariate decine dii giornate a prato. Altri terreni bagnati da fontanili si trovavano verosimilmente in Cortacia, e altri ancora nella vasta tenuta dei Beccuti, nella zona detta Vico Becono, non registrati in catasto poiché interni alla proprietà. Verso queste terre era forse diretta anche la bealera di Valle Morono, anch’essa dei Beccuti, menzionata agli inizi del Quattrocento e derivata dalla Dora a valle del ponte romano in pietra, che potrebbe aver sfruttato un tratto del Po morto. (2.9)
Nelle basse di Dora più prossime a Torino, il toponimo Fontana Gagliarda — attestato fin dal 1202 — sembra alludere a una sorgente e forse a un modesto rivo che serviva la fascia rivierasca omonima. Nel XV secolo compaiono inoltre le tracce di una bealera di San Giorgio e di un'altra detta di San Secondo, forse alimentata dalle acque di deposito di un avvallamento situato al centro del pianalto a nord della Fontana Gagliarda. Più a ovest, verso Vialbe, vi sono indizi di un fossal, e di una bealera che attraversava il territorio di Lucento, di cui si sono perdute le tracce, forse da ricondursi alla successiva bealera di Vialbe. (2.10)
Forme di agricoltura irrigua erano praticate anche a sud della Dora, dove il contado era solcato da corsi d'acqua di origine incerta, verosimilmente riconducibili ai ruscellamenti superficiali delle acque di risorgiva e agli scoli naturali che defluivano nel Po lungo la fascia rivierasca compresa tra ill Valentino e Millefonti. A questi si aggiungevano i fossi e le rogge provenienti dal Fossato Lungo, nonché, dall’inizio del Quattrocento, la bealera di Grugliasco e, in epoca non determinabile, dalla Cossola. Prati irrigui e bealere sono inoltre segnalati nella zona del Drosso, ma — come si è accennato — le conoscenze relative a quest’area rimangono più limitate.

Fig. 2.3 — Il disegno mostra il possibile assetto dell’Oltredora torinese ricostruito dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino. Le irrigazioni più precoci si concentrano presso la regione di confluenza della Stura e della Dora, nell’area corrispondente ai quartieri Regio Parco e Barca, dove le sponde basse e la morfologia pianeggiante facilitavano l’estrazione delle acque. Il Vico Becono (attestato dal 1244) si collocava nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi; la chiesa di Santa Maria Maddalena, l’ospedale di San Lazzaro e il ponte romano in pietra si situavano nell’area delle vie Chivasso e Aosta. Le località dette Fontana Gagliarda (1202) e in Giudeo (1222) erano prossime all’incrocio fra corso Vigevano e via Cigna. Il Castellazzo di Vialbe (1150), e successivamente le cascine Bianchina e Scaravella, occupavano l’area delle torri di raffreddamento Teksid, nel Parco Dora. Il territorio di Aviglio corrispondeva alla parte occidentale del quartiere Vallette, verso Collegno.
Fonte: CDS - Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit.
... e nel Quattrocento
Solo nel XV secolo si verificarono le trasformazioni nel tessuto sociale e negli equilibri dell’élite urbana torinese favorevoli a nuovi investimenti, nel contesto della ripresa legata al ritorno stabile sotto il ducato di Savoia e al rafforzamento del ruolo istituzionale della città, dovuto all’insediamento del Consiglio Cismontano (1431) e dal ritorno dell’Università (1436). In questo periodo maturarono anche i cambiamenti nella proprietà fondiaria — alienazione e la trasformazione delle terre comuni, formazione di poderi più estesi, diffusione della mezzadria — che favorirono l’ammodernamento delle pratiche agricole, il passaggio a forme di coltivazione più remunerative e lo sviluppo della rete idraulica. (2.11)
A monte di Torino dinamiche più precoci anticiparono lo scavo di nuove canalizzazioni al XIV secolo, seppure destinate all’uso esclusivo dei territori comunali. La bealera di Rivoli è documentata dal 1310, mentre quella dei prati di Pianezza risale al 1328. Al 1336 si riferisce l'attestazione di una bealeria Collegii, che irrigava le terre signorili e comunitarie di Collegno. In quel territorio scorreva anche una non meglio precisata bealera Chusellis, per la quale sono documentati diritti di acquaggio nel 1333 e compravendite di ore d’acqua nel 1442. Derivata in epoca imprecisata a Collegno, forse anticipando la prima parte della Putea, essa sfociava nella Dora nella valle di Lucento, sconfinando in territorio torinese. (2.12) Tra le derivazioni più antiche va annoverata anche la bealera Cossola.
Nell’Oltredora, condizioni geomorfologiche sfavorevoli subordinavano la possibilità di nuove aperture alla soluzione delle dispute di confine con Collegno, condizione di sicurezza indispensabile per i Torinesi, i quali — per ragioni altimetriche — erano costretti a collocare le opere di presa al di fuori dei propri confini. Solo negli anni attorno alla metà del Quattrocento vengono infatti costruite la bealera Putea-Canale (1456) e le bealere di Lucento, la Vecchia (1460) e la Nuova (1464), derivate tutte nel territorio collegnese. (2.13)
È dunque il Quattrocento l’epoca alla quale risale la maggior parte delle canalizzazioni extraurbane: oltre a quelle già citate, la bealera di Grugliasco (1416), quella di Caselette e Alpignano (1439), la Barola (1480) e la bealera di Venaria (1498). Ai primi anni del Cinquecento appartengono invece la bealera di Orbassano e la Becchia, entrambe datate al 1507.
Occorre tuttavia sottolineare che le datazioni indicate, basate sui primi documenti disponibili, non sono di per sé probanti e vanno pertanto assunte con cautela: le prime attestazioni raramente sono titoli di concessione e presuppongono quindi un’origine anteriore, non determinabile con certezza. Inoltre, interventi apparentemente ex novo possono in realtà corrispondere a rifacimenti o riassetti di strutture preesistenti, talvolta note con altri nomi.
Analoga prudenza richiedono le menzioni isolate prive di altri riscontri, come il riferimento all’«antico alveo chiamato la Roija, ovvero bealera di Torino» nelle patenti di Ludovico I di Savoia del 24 aprile 1454 (v. scheda), o le fugaci occorrenze di generici viaductum o aqueductus, (2.14) citati magari quali termini di confine — ad esempio nella donazione del 1º dicembre 1221 relativa a un piccolo campo (runcum) «presso l’imbocco della bealera, confinante con la bealera stessa e con la via». (2.15) In simili casi, indizi in apparenza promettenti possono riflettere semplici errori di trascrizione, varianti terminologiche o antiche denominazioni locali oggi indecifrabili, e in mancanza di ulteriori elementi non restano che mere suggestioni.

Fig. 2.4 — La mappa restituisce l’assetto ormai definito della rete dei corsi d’acqua artificiali nell’Oltredora alla fine dell’età medievale, indicando in azzurro chiaro le principali rettifiche della Dora successive al Cinquecento.
Fonte: CDS - Mostra "Appoderamento e Bealere".
Le divagazioni dei fiumi
Occorre infine sottolineare come il sistema idraulico medievale si sia sviluppato in un contesto segnato da tracciati fluviali primitivi spesso differenti da quelli noti, caratterizzati da letti più ampi e ramificati e soggetti a frequenti divagazioni, in larga parte cancellate dagli interventi dell’uomo e dal susseguirsi di piene e inondazioni, come conferma l’uso, in alcune fonti, di aggettivi quali vetus o mortua.
Le ricostruzioni geomorfologiche indicano un marcato spostamento verso sud della Stura di Lanzo, con l'inglobamento del tratto terminale della Ceronda, mentre per il Po si riconoscono tracce di un antico corso occidentale richiamato dal toponimo Po morto. Anche la Dora Riparia, matrice originaria del sistema idraulico torinese, presentava una spiccata ramificazione e spostamenti d'alveo importanti, tra cui quello del tracciato attraversato dal ponte romano in pietra, divenuto inutile in seguito alla migrazione del fiume e demolito nel XIV secolo. (2.16)

Fig. 2.4 — Il disegno della Dora Riparia, benché redatto nei primi anni dell'Ottocento e relativo al tratto tra Rosta e Avigliana, mostra un'inalveazione ben più complessa e articolata di quella attuale. A quell'epoca la morfologia del fiume, non ancora rettificato, modificato e costretto negli angusti argini otto-novecenteschi, probabilmente non risultava troppo dissimile da quella torinese di epoca medievale.
Fonte: Saggio Idrografico del Piemonte di Giuseppe Teresio Michelotti..., Roma, 1803. (particolare)
note 2 _________________________________________
(2.1) Nel Torinese, lo sviluppo dell'alevamento riguardò soprattutto quello ovino, a fronte di una presenza bovina relativamente scarsa. Il consumo di carne di montone non derivava solo dalla comunità locale, ma anche dalle strutture di ospitalità ed accoglienza. Una quota significativa dei capi era, inoltre, esportata. Cfr: R. Comba, L'economia, in Storia di Torino Einaudi, Vol. II, Torino, 1997, pag. 122-124, e A. Barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Viella Ed., Roma, 1995, pp. 95-98.
(2.2) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio (secoli XI-XIII), in: G. Sergi (a cura di), "Storia di Torino", Vol. I, Torino, Einaudi, 1997, pagg. 814.
(2.3) Ivi.
(2.4) Ivi.
(2.5) Si consideri al proposito il consorzio formato attorno al 1382 per lo scavo di una bealera in Vanchiglia, a cui parteciparono vari membri della famiglia Borgesio, un della Rovere e il notaio Tommaso de Pertusio; oppure il ruolo dei Beccuti e degli Scaravelli nello scavo delle bealere di Lucento. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit.(2.4) Si consideri al proposito il consorzio formato attorno al 1382 per lo scavo di una bealera in Vanchiglia, a cui parteciparono vari membri della famiglia Borgesio, un della Rovere e il notaio Tommaso de Pertusio; oppure il ruolo dei Beccuti e degli Scaravelli nello scavo delle bealere di Lucento. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit.
(2.6) Nel 1325 il fitto annuo di sei ore settimanali d’acqua della bealera Colleasca ammontava a 4 grossi tornesi, mentre nel 1332 ne costava 6 per un solo giorno settimanale. Oppure, il reddito ottenuto da Ludovico d’Acaia per l’affitto di 50 giornate di prato passò da 1 fiorino e 5 grossi nel 1418 a 3 fiorini e 4 grossi nel 1420. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit. Sull'argomento si veda anche C. Rotelli, Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450, Einaudi, Torino 1973.
(2.7) M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno: l’avvio dell’irrigazione del pianalto dell’Oltredora torinese, in «Quaderni del CDS», anno II, n. 3, 2003, pp. 5-60.
(2.8) Cfr. M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno... cit. e Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino fino al 1796: Lucento e Madonna di Campagna, a cura del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione, Torino 1997
(2.9) Cfr. M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno... cit.
(2.10) Idem.
(2.11) Idem.
(2.12) Idem. — La zona di Chusellos, (anche Zehirolos, o Jussellos) corrispondeva alla regione delle Vallette, sul confine tra Lucento e Collegno.
(2.12) Il consorzio di gestione rivendicava le Patenti di Amedeo VI di Savoia come atto di concessione della bealera, ma il documento in realtà non offre indicazioni univoche in merito. Con atto del 3 maggio 1464, Aleramo Beccuti, signore di Lucento, autorizzava l’ampliamento e l’allungamento della bealera Vecchia, sino ad allora limitata alla zona di Aviglio, a cavallo del confine tra Torino e Collegno. (ASCT, CS 2677) Lo scavo della bealera Nuova seguiva pochi anni dopo.
(2.13) Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit.
(2.14) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit, pagg. 814.
(2.15) Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, cit., p. 96, doc. 103.
(2.16) Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit. in particolare il cap. 1.
3. Tra origini incerte e rivendicazioni della Città
Le due bealere medievali torinesi — la bealera Colleasca e la bealera Molendinorum — risalgono a epoche e circostanze di cui non si conservano testimonianze scritte. Sebbene il controllo delle acque rientrasse tra le prerogative feudali, la Città di Torino ha rivendicato per secoli la sovranità sulle acque “scorrenti” sul proprio territorio, appellandosi ad antichi diritti di libertà e privilegi imperiali. (3.1) In particolare, in mancanza di prove attendibili, essa ha sostenuto la remota origine della bealera Colleasca con un argomento di palese evidenza: quel canale semplicemente non poteva non esistere. Il territorio, infatti, non sarebbe certamente restato incolto, né privo di sistemi d’irrigazione, date le funzioni essenziali che essa svolgeva per l’agricoltura e per la vita della città fin dai tempi più antichi, talora ricondotti alla contessa Adelaide di Susa — ossia alla seconda metà dell’XI secolo — o addirittura a epoche precedenti. (3.2)
Per quanto simili argomentazioni costituissero dichiarazioni di principio formulate in contesti di contenzioso giuridico, più che con intenti storiografici, riflettono convinzioni profonde e radicate. In effetti, pur prive di un fondamento certo e destinate a restare nel campo delle ipotesi, non mancano di plausibilità logica e storica. E' infatti probabile che, fin dai primi secoli dopo il Mille, un canale convogliasse le acque della Dora verso Torino e il contado più prossimo, attraversando il territorio noto come Colleasca.
Purtroppo, prima del XIV secolo le fonti scritte non offrono un grande aiuto. La prima menzione medievale di un fossatum civitatis — di cui la colonia romana era priva, almeno inizialmente — risale al 1218. (3.3) Collocando lo scavo dei fossati difensivi in quegli anni, e ipotizzando che questi fossero, almeno in certi periodi, adacquati, ciò implicherebbe anche l’esistenza della bealera, poiché solo essa avrebbe potuto fornire l’acqua necessaria. Un'ulteriore traccia è costituita dalla concessione dell'11 luglio 1244, accordata alle monache di Santa Chiara di «un acquedotto per irrigare i beni del monastero situati presso il borgo di Colleasca» — verosimilmente allacciato alla bealera omonima nonostante la formulazione piuttosto generica dell'atto — di cui si tratterà meglio in seguito (vedi par. 4 e nota 4.9).
A ben vedere, qualora lo scavo del bealera fosse avvenuto in età comunale — tra il XII e il XIII secolo — l’assenza di atti di concessione potrebbe essere spiegata con l’autonomia della Città, che non avrebbe richiesto autorizzazioni formali. In assenza di attestazioni dirette, la sua apertura può essere verosimilmente collocata nel corso del XIII secolo, anche in relazione al più ampio contesto di crescita che caratterizza questa fase. In ogni caso, i diritti della Città sulle acque furono definitivamente riconosciuti con le Patenti del conte Amedeo VI di Savoia del 24 marzo 1360 e gli Statuti cittadini dello stesso anno (v. scheda).
Anche l’origine della bealera Molendinorum non è documentata, così come quella dei mulini. L’assenza di concessioni per l'acqua destinata a questi impianti si spiegherebbe tuttavia con la loro originaria appartenenza signorile — totale o parziale, a seconda dei periodi — fino al definitivo passaggio alla Città, avvenuto con le Lettere Patenti della duchessa Violante di Savoia del 21 giugno 1475. Considerazioni analoghe a quelle già esposte valgono anche per questo caso: la funzione annonaria e la produzione di farine rappresentavano un elemento cruciale e irrinunciabile per la sopravvivenza della città. Le prime attestazioni, di natura contabile, risalgono alla fine del Duecento, quando la bealera doveva già esistere da tempo. (3.4)
Sul borgo di S. Donato e Colleasca
Colleasca era il nome medievale del vasto territorio che si estendeva da Torino verso Collegno, delimitato a nord dalla Dora e a sud dalla via di Francia. Il toponimo, derivato dalla «viam Coleascham quam itur Collegium» — l’antica strada che da Torino conduceva a Collegno —, indicava un percorso alternativo, forse più diretto, rispetto alla principale, detta anche via Romea. Per estensione, il nome era esteso anche alla porta di quella città rivolta verso Torino, attraversata dalla strada stessa, alla bealera e al borgo fuori la Porta Segusina. G. Casalis attribuisce la prima menzione della strada a un atto di vendita del 7 novembre 1193, relativo a una «pecia una terrae quae jacet in territorio Taurini inter viam Romeam et via Colleascam. (a) Nella deliberazione consigliare torinese del 7 gennaio 1392, per la nomina di quattro nuovi 'campari' (guardie campestri), la sua estensione è indicata «dal ponte del Po fino a Putei Strate (Pozzo Strada) verso la Dora».
Il «Burgus Sancti Donati»
Torino, piccola città rurale, non conobbe l'intenso sviluppo borghigiano di altri centri dell'Italia settentrionale, basato su insediamenti di una certa consistenza demografica, con mercati di medio raggio e significative funzioni produttive, artigianali e urbane. Tra i nuclei foranei torinesi, il più rilevante era il «burgus Sancti Donati», noto anche come «burgus Coleasche», «suburbius Porte Secusine», «burgus Taurini», o semplicemente «burgus», sottintendendo che fosse il più importante, il borgo per antonomasia. (aa)
La sua formazione è collegata al transito di persone e merci lungo la via di Francia, principale ragion d’essere della stessa Torino. Situato «foris et prope muros civitatis» - all’angolo sudoccidentale delle fortificazioni, dove in seguito fu edificato il mastio della cittadella - il borgo aveva origini strettamente legate all'abbazia di San Solutore Maggiore, centro religioso e potente proprietario terriero. (b) Le prime attestazioni di un agglomerato urbano denominato «della Colleasca» risalgono al XII secolo, con le cessioni dei terreni abbaziali su cui sorsero i primi edifici attorno alla chiesa di San Donato. (c) La prima menzione specifica di un «burgo Sancti Donati» compare nel 1171, in un contratto con cui l’abate Niccolò concedeva in censo una piccola pezza di terra «iusta domo ecclesie Sancti Donati»; altre attestazioni seguiranno, sempre nel quadro delle operazioni fondiarie benedettine. (d)
Le principali notizie sul borgo si devono a L. Cibrario, secondo cui:
«Volgendo a mezzodì, e seguitando il corso delle mura a ponente, incontravasi a diritta della strada di Rivoli il borgo di S. Donato e di Colleasca, che protendevasi verso il Martinetto, ed era formato d’una sola strada che chiudevasi con una porta. Eranvi in quel borgo la chiesa di San Donato, la chiesa e lo spedale di San Cristoforo dell’ordine degli Umiliati, la chiesa di San Bernardo di Mentone, (e) soggetta al preposto di Montegiove (Gran S. Bernardo). In quel borgo si tennero in alcun tempo le donne mondane». (f)
È oggetto di discussione se «S. Donato» e «Colleasca» costituissero un unico agglomerato o due insediamenti distinti. Un elemento utile si trova nell’Ordinato del 24 novembre 1333, che disponeva la fortificazione delle porte «del borgo di San Donato e Colleasca» (g). Non è tuttavia da escludere che il doppio appellativo rifletta la fusione di due nuclei originariamente indipendenti, confluiti in seguito in un unico suburbio di maggiori dimensioni.
3.1 Luigi Cibrario, nell'ipotetica rico-struzione della Torino del 1335, colloca il borgo di San Donato e Colleasca fuori la porta Segusina, «a diritta della strada di Rivoli», ovvero tra questa e la Dora. Il suburbio ospitava le maggiori chiese e i conventi extraurbani sulla direttrice di Francia. Il Cibrario non precisa i con-fini del borgo, osservando soltanto che era «formato d’una sola strada che chiu-devasi con una porta». È possibile che alcuni edifici religiosi si trovassero nei pressi, ma al di fuori dell'agglomerato. La sovrapposizione cartografica colloca l'area tra i corsi Palestro e Regina Margherita e le vie della Consolata e Garibaldi. È importante sottolineare che ricostruzioni di questo tipo restano con-getturali, poichè si basano sulla paziente e meticolosa interpretazione e ricompo-sizione di frammenti documentali, ma non su dati oggettivi, ritrovamenti ar-cheologici o su effettive basi cartografi-che. Inevitabilmente soggette a margini di errore, simili ricostruzioni offrono una visione d’insieme, ma hanno valore topografico indicativo. A questo propo-
.jpg)
sito, è interessante notare che il Cibrario tracciava qui un perimetro urbano di epoca medievale più ridotto di quello romano, un'ipotesi che in seguito egli stesso abbandonò.
Un nodo strategico tra accoglienza e commercio
L’esistenza del borgo era motivata soprattutto da ragioni di passaggio e commerciali. La sua formazione, alla fine del XII secolo, coincise con l’inserimento dell’itinerario torinese della via Francigena tra le rotte della nascente rivoluzione commerciale europea. Per i mercanti astigiani e genovesi – tra i primi italiani a frequentare le celebri fiere della Champagne – il percorso valsusino rappresentava la via più diretta per l’Europa centro-settentrionale. Il sobborgo si trovò così in una posizione strategica, fuori la porta urbica occidentale e alla convergenza delle strade provenienti dalla Valle di Susa: sia quelle sulla sponda destra della Dora, che passavano alternativamente per Rivoli, Collegno, Grugliasco o Beinasco, sia quella sulla sponda sinistra, che attraversava Pianezza e guadava in qualche punto il fiume. (Cfr. Guadi sulla Dora)
L'agglomerato era formato da semplici edifici rurali, quali «tecta», «domuncule» e «airali», intercalati da coltivi, orti, frutteti e discariche, attraversato da un capo all’altro dalla strada di Collegno, frequentemente allagata e danneggiata dalle esondazioni della bealera che la correva al suo fianco. Vi trovavano spazio attività commerciali, accanto a importanti istituzioni religiose e di assistenza. Un ruolo cruciale spettava agli ospedali, che offrivano ospitalità e assistenza a viandanti e pellegrini e, grazie a consistenti dotazioni patrimoniali, assicuravano cibo, alloggio, protezione e sostegno a orfani, vedove, poveri, disabili ed emarginati. Pur fornendo anche cure sanitarie, la loro missione principale rimaneva di natura caritativa e sociale. (h)
Le strutture e gli esercizi di natura commerciale e laica erano anch’essi finalizzati al flusso di viaggiatori e merci: negozi di vario genere, fornai, calzolai, barbieri e cerusici, bordelli, taverne, mescite e alloggiamenti integravano quelli torinesi, contribuendo a tenere fuori dalla città funzioni e persone potenzialmente fonte di disturbo. (i) La prostituzione era così diffusa che gli Statuti del 1360 vietarono alle «meretrici» di esercitare nel borgo. Anche le botteghe artigiane e i servizi — innanzitutto quelli che richiedevano ampie superfici — erano rivolti principalmente ai trasporti e ai transiti: numerosi dovevano essere gli stallaggi, i magazzini e i depositi, oltre alle botteghe di fabbri, maniscalchi, sellai e carradori. Non si hanno invece notizie di attività manifatturiere volte alla trasformazione delle merci in transito, a conferma della vocazione dell'abitato come luogo di passaggio e servizio piuttosto che di produzione.

.jpg)
3.2 La mappatura ottocentesca del borgo di S. Donato, riferita al 1416 e realizzata da Pietro Bagetti, differisce da quella del Cibrario per l'aggiunta delle chiese di S. Agostino e di S. Rolandino, del convento di S. Valeriano e dell'oratorio di S. Nico-la, omettendo però la chiesa di S. Dona-to. I principali edifici religiosi del «fau-bourg de la porte Susine» si distribui-scono lungo le strade di Rivoli e di Col-legno. Proiettato sull'attuale stradario torinese, l'insediamento si collocherebbe tra corso Palestro e piazza Statuto.
Le funzioni difensive
Sebbene manchino informazioni precise su confini ed estensione, è certo che l'insediamento si trovasse in prossimità della porta Segusina. Era chiuso da un'unica porta rivolta a ovest, verso Pozzo Strada, (m) edificata con deliberazione del Consiglio del 23 novembre 1333 «per la custodia del borgo». L'opera rientrava in un più ampio piano di rafforzamento delle difese cittadine, (n) e potrebbe aver sostituito un ponte o un accesso preesistenti, oppure essere stata realizzata contestualmente allo scavo di un fossato attorno al suburbio stesso.
La presenza di una porta di accesso suggerisce l'esistenza di una fortificazione. Tuttavia, il fatto che fosse l'unica desta qualche perplessità, immaginando le difficoltà facilmente causate dal transito di persone, carri e animali provenienti da direzioni opposte, costretti a utilizzare lo stesso varco. Soprattutto se si considera che l'apertura di un secondo passaggio non avrebbe comportato particolari ostacoli. Tuttavia, una tale configurazione trova spiegazione se l’insediamento fosse stato circondato da un fossato, collegato senza soluzione di continuità a quello cittadino.
Il disegno di una linea di difensa continua e coerente che includesse anche il borgo, trova diverse conferme. Gli Ordinati del 14 aprile 1339 menzionano un «fossatum burgi Taurini» collegato a quelli torinesi «e ad altri». Ulteriori riscontri provengono da una compravendita del 19 dicembre 1218, relativa a «un campo situato vicino al fossato della città di Torino, confinante con il fossato del borgo e la via di Sant'Andrea», (o) e dalla cessione del 1223, da parte dell'Abate di San Solutore, della metà di una casa e di un terreno adiacenti «al fossato di Borgo San Donato». (p) L'ipotesi della continuità delle trincee è avvalorata dalla partecipazione del Monastero alle spese per lo scavo di nuove linee di difesa perimetrali di Torino. (q) Un’ulteriore traccia emerge dal verbale del Consiglio del 31 dicembre 1387, relativo al taglio abusivo di alberi avvenuto sulla sponda della bealera Colleasca «accanto al campo di San Solutore Maggiore... lungo la riva dei fossati del borgo di San Donato.
Le funzioni del borgo di San Donato e Colleasca mostrano un'integrazione con Torino che non si limitava all'assistenza ai pellegrini e al traffico commerciale. Il ruolo strategico-militare lo qualificava infatti come un'estensione organica della città, e spiega forse perché la Porta Colleasca sia stata talvolta erroneamente annoverata tra le porte torinesi medievali.
Fig. 3.3 Il disegno mostra le proprietà dei frati Umiliati nei pressi della Porta Segusina. Dopo il loro allontanamento, avvenuto nel 1427, i beni furono divisi tra gli Eremitani di Sant'Agostino e le monache di S. Chiara. Pur essendo redatto nel 1708 da Antonio Bertola, il disegno colloca con precisione il convento, la chiesa e l’ospedale di San Cristoforo – tutte proprietà dell'Ordine e tra le maggiori istituzioni religiose fuori la Porta Segusina
Fonte: AST, Sez. Riunite, (particolare)
(cliccare sull'immagine per andare all'originale).
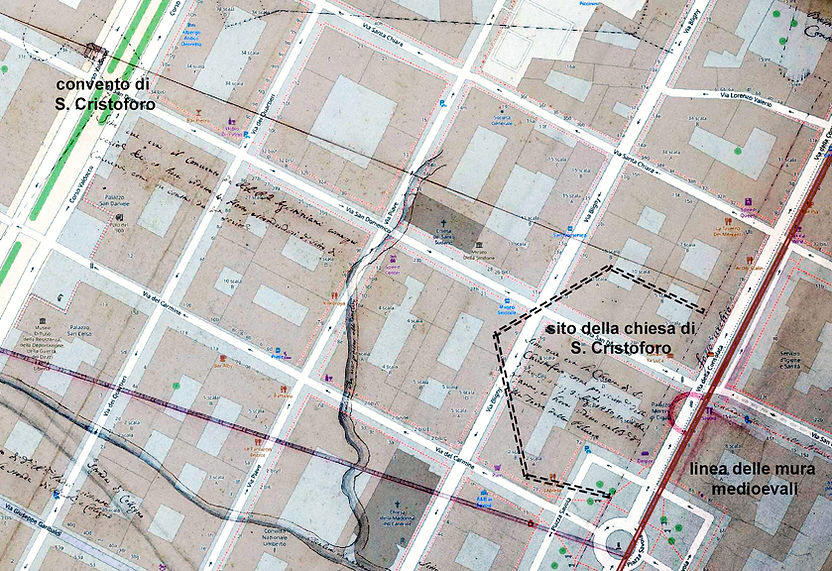.jpg)
3.4 L'ingrandimento del disegno, proiettato sull'odierna mappa stradale di Torino, mostra l'ubicazione degli edifici di San Cristoforo in relazione all'alveo della bealera Colleasca, alle strade di Collegno e Rivoli, alla porta urbica occidentale e alla cinta muraria. Il convento sorgeva all'incrocio tra via San Domenico e c.so Valdocco, mentre la chiesa e l'ospedale erano situati sull'asse di via San Domenico, nel perimetro delimitato dalle attuali vie Bligny, Santa Chiara, della Consolata e del Carmine.
Il borgo scomparve durante l'occupazione francese del 1536, e la stessa sorte toccò agli altri edifici e insediamenti situati fuori le mura, compresi quelli religiosi. L'abbattimento pose probabilmente termine a un lento declino già in atto, e faceva parte di un più ampio progetto di rafforzamento e ammodernamento delle fortificazioni. Le nuove strategie militari basate sulle armi da fuoco richiedevano infatti ampi spazi liberi davanti alle mura, privi di ostacoli che potessero interferire con il tiro delle artiglierie o offrire riparo agli assalitori. In questo contesto, furono demoliti anche l'abbazia di San Solutore Maggiore e le vestigia della romanità sopravvissute fino a quel momento. (r) Di tali testimonianze — il monastero, il borgo e l'antico assetto territoriale medievale — non ci è giunta alcuna traccia materiale.
note __________________________________________
(a) Cfr. Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, Vol. 5, G. Maspero e G. Marzorati, Torino, 1839, p. 343.
(aa) Cfr. M.T. Bonardi, Canali e macchine idrauliche nel paesaggio suburbano, in "Acque, ruote e mulini a Torino, vol. 1, a cura di Giuseppe Bracco, Torino, Archivio storico della Città di Torino, 1988. pag. 108.
(b) L'abbazia di San Solutore Maggiore fu fondata dal vescovo Gesone tra il X e l'XI secolo sulle rovine di una precedente chiesa dedicata ai santi martiri protettori della città, Solutore, Avventore e Ottavio, ottenendo dignità abbaziale alla fine del XIII secolo.
(c) La chiesa di San Donato è elencata per la prima volta tra i beni di San Solutore nel 1118. Inoltre, viene menzionata nuovamente in un contratto del 1126, con cui l'Abate cede in enfiteusi un sedime con edificio e cortile situato non lontano dalla chiesa. Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore: origini, rapporti, sviluppi patrimoniali, in: "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CIII (2005), pp. 325-400.
(d) Nel 1196 l’abate Gualfredo concesse in censo una pezza di terra con casa, cortile e pertinenze nei pressi della Porta Segusina. Nel corso del XIII secolo il Borgo San Donato è citato in vari atti di accensamento o vendita: a volte si trattava di pezze di terra vuote, altre volte di edifici. Nel 1222 l’abate Pietro acquistò una confinante col fossato del comune di Torino, e l'anno successivo la metà di una casa e le sue pertinenze, confinanti col fossato di Borgo San Donato. Cfr. P Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, Op.cit. Nel 1182, inoltre, si ha notizia di una pezza di terra con casa situata «in via Colleasca». Cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, op. cit., p. 754.
(e) La località è situata sul lago di Annecy, in Alta Savoia.
(f) Cfr. L. Cibrario, Storia di Torino, vol. II, A. Fontana Editore, Torino, 1846, p. 24. — Il borgo ospitava forse anche le chiese suburbane di San Pancrazio, Sant’Augustino, di San Francesco (poi di Santa Chiara) e l’oratorio di San Nicola, collocate tutte fuori la Porta Segusina. Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, op. cit. p. 812. — Sempre a ridosso della porta urbica occidentale, F. Pingone indica la presenza del cenobio di San Rolandino e «il tempio del Sepolcro di Gerusalemme, abitato da coloro che portavano come insegna la croce rossa», situato però situato a Pozzo Strada, quindi a una distanza sensibilmente maggiore da Torino. Cfr. F. Pingone, Augusta Taurinorum, 1577. — G. Donna D’Olderico ritiene che, in origine, il nome del borgo fosse di San Bernardo, in riferimento al priorato e alla casa ospitaliera dipendenti dall’Ospizio del Gran San Bernardo. La denominazione di borgo San Donato sarebbe poi prevalsa, in virtù della buona fama della confraternita omonima titolare di numerose proprietà nell’area e dedita all’assistenza a poveri e ammalati. Va tuttavia osservato che, pur considerando attendibili le fonti a cui attinge, l’interpretazione che ne dà l'autore non sembra altrettanto convincente. Cfr. G. Donna D’Olderico, Nota introduttiva all’opuscolo di L. Cibrario dedicato agli Ospedali di Torino nel XIV secolo del 1836, ristampato nel 1963 negli "Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino e della Società Storica delle valli di Lanzo", p.11.
(g) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. II, pp. 49. Altre citazioni si trovano alle pagg. 99 e 193.
(h) L'ospedale di San Cristoforo, ad esempio, possedeva complessivamente 265 giornate di terra, di cui 93 nella regione Colleasca. Oltre a numerose vigne e airali e a sei case, deteneva anche il diritto di riscossione dei canoni di affitto in natura — vino, grano e segala — su varie proprietà a Torino e Collegno. Cfr. G. Donna D’Olderico, Nota introduttiva all’opuscolo di L. Cibrario, op. cit. p. 9.
(i) I Consegnamenti catastali trecenteschi non registrano vere e proprie strutture alberghiere all'interno di Torino, ma soltanto i pochi letti denunciati da qualche contribuente. Cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, op. cit. p. 764.
(l) Tuttavia, nel 1412 il Comune decise di dedicare una casa ad postribulum, in seguito alla creazione dell'Università e alla venuta degli studenti. Cfr. R. Comba, Apetitus libidinis coherceatur. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale, in "Studi Storici", XXVII (1986), pp. 568 segg.
(m) Cfr. M.T. Bonardi, Canali e macchine idrauliche nel paesaggio suburbano, cit. p. 119. — Nell'ipotesi che il borgo avesse un unica porta rivolta verso Pozzo Strada e l’ospedale del Santo Sepolcro, andrebbe forse riconsiderata la posizione del bivio che separava le strade di Rivoli e Collegno. Il bivio, anziché a ridosso della porta urbica (come suggeriscono alcune ricostruzioni storiche, fig. 3.2) andrebbe collocato più ad ovest, fuori della porta del borgo, corrispondendo così alle furcas de Puteo Strate, da cui si per l'appunto diramavano la via Colleasca e la via Romeria. Tale configurazione risulterebbe coerente con la natura commerciale, ospedaliera e di transito del borgo stesso.
(n) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. II, pp. 93.
(o) Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1912, Pinerolo, p. 86.
(p) Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, cit. p. 39. — Circa la presenza di fossati attorno ai borghi fuori le mura cfr. anche: A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit. p. 789, nota 8.
(q) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit. p. 789.
(r) A questo proposito, F. Pingone narra: «Quattro sobborghi sono stati rasi al suolo: uno presso la Porta Secusina, dove si trovava il cenobio di San Rolandino; il tempio del Sepolcro di Gerusalemme, abitato da coloro che portavano come insegna la croce rossa; il tempio di San Bernardo; il monastero di Sant'Agostino; il cenobio di San Solutore, della Legione Tebea dell'Ordine di San Benedetto; e quello di San Valeriano Abate». (Cfr. F. Pingone, Augusta Taurinorum, Torino, 1577, p. 77). Nei quattro sobborghi attorno alla città complessivamente andarono distrutte tredici antichissime chiese e vari altri antichi edifici.
note 3 __________________________________________
(3.1) Cfr. Diplomi imperiali concessi da Enrico IV nel 1111, confermati da Enrico V nel 1116 e ancora da Lotario III nel 1136. Cfr. ASCT, CS 1 e CS 2212 cart. 129 — Nei privilegi imperiali del 30 giugno 1116 si ordinava genericamente che «nessun vescovo, duca, marchese, conte, visconte, gastaldo o persona grande o piccola osi turbare, molestare o privare i cittadini torinesi della giustizia e dei diritti a loro concessi», sotto pena di cento libbre d’oro, da pagarsi per metà Camera imperiale e l’altra parte ai Torinesi. Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1912, Pinerolo, pag. 7, doc. 22.
(3.2) Cfr. ASCT, CS 1854 — A tal prposito sono eloquenti dichiarazioni quali «E' provato da antichissimo tempo la Città di Torino esser stata, ed esser in quiete, e pacifico possesso della Bealera Pellerina ‘sij Colleasca e Fossato longo, et de suoi bochetti, rippaggij, argini e fossali». (Anno 1488, ASCT, CS 1845) oppure «La Città, Cittadini, e particolari essere in antichissimo, ed immemorial uso, e il giusto, e pacifico possesso di tutte le acque, talmente che non v’è memoria d'uomo, né di scritture in contrario, e si può probabilmente dire, ed assicurare, che tale uso, e possesso abbia avuto principio con la medesima Città, e Particolari suddetti, e poiché non si trova, che mai dette acque siano state d’altri, che della città, e particolari suddetti; il che quando eziandio non vi fosse altro, a forza il giusto titolo, e causa» (Anno 1629, ASCT, CS 1972). E' interessante osservare che, a ulteriore riprova, nel 1839, la Commissione Pernigotti ritenne sufficiente un'osservazione quasi identica — «si ha fondato argomento per credere che l'origine sia remotissima e di molto anteriore all'epoca che la Città di Torino fosse compresa nei domini dei Conti di Savoia» — per riconoscerne ufficialmente i diritti vantati sul canale proveniente dalla Pellerina e su quelli collegati. — Tra le raccolte storico-giuridiche sul tema, cfr. ASCT, CS 1845 e AST, Sez. Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Feudalità, Articolo 766 - Atti di visita e titoli riguardanti acque, bealere, mulini e canali, Paragrafo 2 - Titoli riguardanti le derivazioni d'acqua dalla Dora, m. 2.
(3.3) Risale al 1218 la menzione di un campo iuxta fossatum civitatis. Cfr. (Storia di Torino Einaudi, vol 1, p. 788-789.
(3.4) Cfr. Acque ruote e mulini a Torino, cit, saggi vari.
4. Il luogo di presa
Molto della bealera Colleasca rimane incerto. Non si hanno informazioni attendibili sul periodo di costruzione, né sul luogo di presa, né sulle caratteristiche. Le prime attestazioni documentali suggeriscono uno scavo anteriore al XIV secolo, anticipabile forse al secolo precedente, in concomitanza con lo scavo del fossato attorno le mura, come verrà discusso più avanti. In ogni caso, la conformazione del territorio lascia ipotizzare un tracciato non troppo diverso da quello della canalizzazione derivata in seguito dalla Pellerina, all'interno dei confini torinesi, e diretta verso la città.
Anche le ipotesi sulla collocazione dell'imbocco sono condizionate da fattori idro-morfologici. La presa doveva trovarsi infatti almeno un miglio a monte della città, in un punto sufficientemente elevato da permettere alle acque di superare il dislivello tra il letto del fiume e il pianalto di Torino. Pur considerando le conoscenze incomplete sul corso storico della Dora e gli effetti delle modifiche d’alveo succedutesi nel tempo, è verosimile che la bealera avesse origine in un'area che dall’attuale parco della Pellerina si estende verso il confine con Collegno: ragioni di sicurezza e di controllo rendono infatti improbabile una captazione delle acque fuori dal comune. (4.1)
Ficca Pellerina o ficca Colleasca?
In via preliminare, è importante osservare che non si hanno notizie di una ficha Colleasche, ed è probabile che una traversa fluviale con questo nome non sia mai esistita. (4.2) Quella che con ogni probabilità rappresenta la prima menzione dell'origine la bealera Colleasca, contenuta in una concessione d'acqua del 1321, attesta genericamente l'esistenza di una «ficha Magne Durie posita, iuxta Bichocham». (4.3) La presenza di un solo sbarramento sul corso della Dora non richiedeva ulteriori indicazioni, se non il riferimento a una bicocha, una postazione di guardia collocata a sorveglianza di un guado, parte di un sistema di avvistamento extraurbano di ampio raggio. (4.4) L. Cibrario descrive queste strutture come «guardiole di legno, erette sopra gli alberi, o innalzate su pali e cinte d'un fosso, il tutto a fine di specular da lunge i moti del nemico, de' quali con segni di bandiere, di fumo o di fuoco davano ragguaglio le vedette esterne alle interne. Due bicoche s'alzavano sempre al guado della Pellegrina in riva a Dora (verso Altessano) e ne' prati di Vanchiglia». (4.5)
Le citazioni di una ficha Pelerine diventano frequenti dalla seconda metà del Trecento. Il toponimo "Pellerina" si ritiene derivi dalla contrazione di "Pellegrina", con evidente riferimento ai viaggiatori con fini religiosi. (4.6) Le menzioni della prima metà del secolo non riguardano ancora l'area nota oggi con questo nome — allora chiamata Valdoc e forse al Choo — ma un guado sulla Dora verosimilmente preferito dai viandanti diretti verso Roma, la Terra Santa o Santiago di Compostela. Coerentemente con la funzione svolta, la bicocha Pelerine sorgeva sulla sponda destra della Dora, in territorio Taurini ubi dicitur ad Motam, cioè su una collinetta, o comunque in posizione sopraelevata ai margini del territorio torinese. (4.7)
Sotto il profilo idraulico, è probabile che la derivazione avvenisse in modo molto semplice, favorita spontaneamente da una divagazione secondaria del fiume o da una posizione d’ansa, più adatta alla captazione dell’acqua rispetto a un tratto rettilineo. Non sappiamo se a sbarrare il fiume fosse una palizzata in legno o un rudimentale "invito", formato soltanto da un allineamento di massi, come ipotizzato per la bealera Cossola. Una soluzione di questo tipo, leggera e "instabile", diversa da una traversa fluviale vera e propria, non avrebbe richiesto molta manutenzione o riparazioni impegnative, di cui infatti restano poche tracce nei primi anni degli Ordinati. Portate d'acqua più consistenti — dovute a precipitazioni più abbondanti e a minori prelievi a monte — avrebbero in ogni caso consentito la derivazione anche con modeste opere di presa.
Il luogo di imbocco più plausibile è alla fine dell’odierno corso Appio Claudio, dove aveva inizio il canale della Pellerina. Tuttavia, sebbene meno probabile, non è da escludere una posizione più a monte, all'estremo confine occidentale torinese, nell’area delle cascine Mineur e Cascinotto, dove la strada della Pellerina piega bruscamente in strada della Berlia. Una derivazione ancora più arretrata, presso l’attuale cascina Ferraris, sarebbe stata possibile solo se allora l’area fosse rientrata nella giurisdizione torinese. (fig. 4.1)


4.1 Ipotesi del luogo di imbocco della ficha Pellerine. Il punto A, sicuramente il più probabile, corrisponde allo sbarramento del canale della Pellerina ancora esistente; il punto B segnala una possibile posizione a monte nei pressi delle cascine Mineur e Cascinotto; il punto C rappresenta un’ulteriore ipotesi a ovest nelle vicinanze della cascina Ferraris
Un'ipotesi non confermata
In passato, gli storici — forse saggiamente, data la scarsità delle fonti — hanno evitato di pronunciarsi sull'origine e sul tracciato della bealera Colleasca. Recentemente è stata formulata l'ipotesi che prendesse questo nome una canalizzazione autonoma e indipendente da quella proveniente dalla Pellerina, e precisamente un antico ramo della bealera Cossola che, proveniente da Collegno, avrebbe attraversato l'intero pianalto occidentale fino a raggiungere il territorio a sud-ovest di Torino. (4.8)
Questa interpretazione si basa su due elementi. Il primo è la concessione fatta dalla Città di Torino alle monache di Santa Chiara, datata 11 luglio 1244, di «un acquedotto per irrigare i beni del monastero situati presso il borgo di Colleasca», in un luogo difficilmente raggiungibile dalle acque della Pellerina. Il secondo elemento è la presenza nella cartografia del XVIII secolo di un ramo della bealera Cossola chiamato Colleasca, compatibile con le funzioni irrigue descritte. Tuttavia, queste evidenze non sembrano sufficienti a confermare l’ipotesi, (4.9) né a contraddire l’interpretazione, condivisa e supportata dalla documentazione, secondo cui la «Bealerie Coleasche, che si dipartiva dalla ficha Magne Durie, situata presso la bichocha, verso Torino, e il Fossatum longum» fosse la sola canalizzazione medievale della città.
L'assegnazione di due diversi nomi alla stessa canalizzazione può apparire contraddittoria, ma non deve sorprendere, trattandosi di un fenomeno non certo inusuale. "Bealera Colleasca" rappresenta il nome più antico, legato all'appellativo medievale del territorio e del borgo attraversati, mentre "bealera Pellerina" si afferma nella seconda metà del XIV secolo, risultando dunque più recente. Si può supporre che i due idronimi designassero tratti diversi della medesima derivazione, oppure — come spesso accade in ambito geografico — che il nome di un particolare si sia esteso poi al tutto, dal luogo di presa all'intero corso d'acqua. In ogni caso, nelle fonti trecentesche i due termini risultano spesso usati come sinonimi, e la continuità idraulica tra la ficca Pellerina e la bealera Colleasca trova numerose conferme. (4.10)
D’altra parte, a partire dal XV secolo, il nuovo nome di “bealera del Martinetto” iniziò a sostituire l’antica denominazione. La scomparsa del borgo Colleasca accelerò il processo; tuttavia l’appellativo originario non fu completamente abbandonato, se ancora fin oltre il Seicento la canalizzazione è talora citata come «bealera Colleasca, ossia del Martinetto» (4.10)
note 4 __________________________________________
(4.1) Sotto questa condizione, la collocazione della presa della bealera a Collegno sembra possibile solo dopo il 1262, anno in cui Torino riscattò il castello e il «luogo di Collegno» dagli eredi di Aimerico de Crusinaldo. Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino fino al 1796: Lucento e Madonna di Campagna, a cura del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione, Torino 1997, p. 33 e segg.
(4.2) Le menzioni di una ficha Coleasche contenute in alcune verbalizzazioni degli Ordinati tardo trecenteschi si riferiscono senza dubbio alla "ficca Pellerina".
(4.3) Cfr. ASCT, CS 1869 — Il termine latino Duria indicava genericamente un corso d'acqua. La Magne Durie, designava la "Grande Dora", ossia la Dora Riparia, distinguendola così dalle canalizzazioni minori e in particolare dalla Doira che attraversava la città seguendo l'antico decumano maximo.
(4.4) Per il sistema complessivo delle struttura di avvistamento cfr. M.T. Bonardi, A, Settia, La città e il suo territorio, op. cit. pag. 72. — G. Casalis colloca le altre guardie: «nella selva di Mischie, presso S. Mauro», «al ponte di Stura sul campanile di santa Maria», «sulla torre di Pozzo di Strada», «sulla sponda della Dora alla ficca Pellegrina» e un'altra «nei prati di Vanchiglia». Cfr. Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, Vol. 21, G. Maspero e G. Marzorati, Torino, 1851, p. 238. — Tutti questi punti di osservazione si trovavano, non certo casualmente, su strade che conducevano alla città.
(4.5) Cfr. L. Cibrario, Storia di Torino, vol. I, p. 372.
(4.6) Va osservato, che a quel tempo, 'Pelerinus' era un nome proprio molto diffuso, e che il toponimo potrebbe avere un'origine più prosaica.
(4.7 Il termine mota ricorre di frequente nella documentazione (ad esempio terra quae iacet prope motam, mota Aynardi...) e sembra riferirsi a un elemento territoriale sopraelevato oppure a un accumulo di detriti naturalmente trasportati dal fiume oppure ancora a una collinetta artificiale. Gli storici non concordano invece sull'uso, in Piemonte, del termine nell'accezione di complesso rurale fortificato, come avviene in altre parti d’Italia.
(4.8) Cfr. L. Lombardelli, C. Vigo, Canali e acque nella Torino medievale, in "Gruppo Archeologico Torinese, op. cit.", vol. I, pag. 156 e segg.; C. Vigo, Publica Strata. Itinerario storico e archeologico fra Torino e Collegno, Gruppo Archeologico Torinese, Torino, 2005, pagg. 26-27 e G. Sacchi, Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino, cit., pagg. 33 e segg.
(4.9) L'assunto della concessione del 1244 è che le terre delle Clarisse si trovassero in una parte del pianalto lontana dalla città, che per motivi di livellazione non avrebbe potuto essere irrigata dalle acque della Pellerina. Nell'area della Colleasca, i possedimenti delle monache erano estesi e numerosi. Un censimento del 1697 elenca tra gli altri, «una cassina nelle fini di Torino detta Colleasca al Martinetto» — poi nota come l'Ormea — con annesse 227 giornate e 5 tavole di orti, prati, campi, alteni, boschi e un canapile. Questa proprietà, «in antichissimo possesso» dell'Ordine, situata genericamente fuori Porta Susina — «in Colleasca» — usufruiva di 48 ore settimanali d'acqua della Cossola, e per posizione e approvvigionamento idrico sarebbe stata compatibile con l'atto in questione. (Cfr. Libro delle proprietà del Monastero di Santa Chiara, AST, sez. Corte, Materie ecclesiastiche, Monache diverse, Torino, Monache Clarisse di Torino, mazzo 6, fasc. 1, p.5-6). Un altro possedimento dell'Ordine, la «cassina di Pozzo Strada», con le 29 giornate e 32 tavole di terra, parte delle quali a Lucento, godeva anch’essa di dodici ore settimanali d'acqua della bealera, tuttavia, era stata acquistata dal conte Pastoris Mura solo dieci anni prima, e pertanto è esclusa. (cfr. Libro delle proprietà del Monastero di Santa Chiara, cit. p. 10-13). Non si hanno notizie circa la dislocazione delle proprietà dell'Ordine in epoche più antiche, ma è plausibile che si concentrassero innanzitutto in prossimità della città e del monastero. Il documento del 1244, citato da G. Casalis nel Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna (Vol. XXI, p. 616), del 1851, originariamente conservato nell'archivio del monastero, oggi non è più reperibile e non può essere d'aiuto. La richiesta delle «Signore badesse e monache di Santa Chiara di Torino», menzionata negli Ordinati del 15 maggio 1374, di ottenere l'investitura della «loro acqua, che percepiscono dalla bealera comunale ogni giovedì, pagando il canone consueto», sembra un rinnovo della concessione del 1244. L'esplicito riferimento alla «bealera comunale» è dirimente, perché la Cossola, la cui esistenza nel XIII secolo non è affatto dimostrata, apparteneva a proprietari terrieri privati, e la Città non avrebbe potuto avere voce in capitolo su di essa. — Per inciso, il Consiglio acconsentì e, pur negando l’investitura formale, confermò il diritto delle monache di continuare a prelevare e usare «la solita acqua» alle condizioni usuali. (cfr. ASCT, Liber Consigliorum 1372-1375.
La bealera Cossola deriva dalla Dora ai piedi del Castello di Collegno. In prossimità della cascina Colomba, a Pozzo Strada, si divideva in cinque rami, uno dei quali, chiamato per l’appunto "Colleasca", irrigava le proprietà distribuite sul pianalto occidentale, raggiungendo l'area di p.za Statuto. Le origini di questa canalizzazione rimangono incerte a causa dell'incendio che nel 1799 distrusse gran parte della documentazione custodita nell'archivio storico del consorzio di gestione, e pertanto poco sappiamo dei tracciati dei secoli precedenti. Uno studio ottocentesco ha ipotizzato che questa bealera fosse la più antica di tutte, addirittura anteriore al dominio di Oddone di Savoia. Tuttavia, tale indagine mirava a dimostrare la preminenza dei diritti di derivazione, e poteva forse non essere imparziale, ma soprattutto si fondava su speculazioni teoriche, non supportate da prove concrete. (Cfr: ASCT, Consorzio bealere, Consorzio bealera Cossola, cart. 1, fascicoli 1/14 e 1/13, Memoriale di Maurizio Valletti tendente a provare l’antichissima origine della Bealera Cossola, 1852). Sicuramente la Cossola è tra le derivazioni più antiche, e la sua origine è medievale, ma le prime compravendite d'acqua risalgono solamente al 1498. Inoltre, la lunga galleria scavata nella pudinga — la roccia dura e compatta sotto il castello di Collegno — attraversata dal tratto iniziale dalla bealera, è considerata un'opera di notevole rilievo ingegneristico, che è lecito dubitare possa essere realizzata con mezzi e tecniche dei primi secoli dell'era volgare. Una bealera Colleasca autonoma e indipendente, altro elemento fondamentale della tesi in questione, è attestata soltanto dalla cartografia settecentesca, con esplicito riferimento alla Carta corografica del territorio di Torino di Amedeo Grossi del 1791. Tale attestazione, sebbene obbligata, è discutibile che possa postularne la sussistenza già nel periodo medievale. Infine, non è certo irrilevante non si abbiano notizie della partecipazione della Città di Torino alla gestione di questa bealera, né tracce di un'ipotetica derivazione collegnese negli Ordinati e nei Consegnamenti della Città di Torino o in altri documenti dell'epoca. In definitiva, se gli elementi addotti non sembrano sufficienti a confermare la tesi in esame, per contro sono numerosi quelli che la contraddicono o, quantomeno, la mettono in dubbio.
(4.10) Negli Ordinati non mancano esempi che associano i toponimi "Colleasca" e "Pellerina" alla canalizzazione al servizio della città e delle campagne torinesi. Tra gli altri: il 14 novembre 1372 si organizza una royda per la cura della bealeriam Coleasche et Pellerine; il 1° maggio 1373 si segnalano danneggiamenti alla bealeriam Coleasche comunis Taurini, e si ordina un'ispezione all'argine della "bealera della Pelerina" andato distrutto; il 24 settembre 1382 si dispone il controllo della bealeriam Coleasche usque ad ficham Pelerine; infine, decisiva è la prova del 15 agosto 1390, quando, accertata la rottura della fiche della bealera Coleasche, viene approvato un prestito forzoso a carico degli utenti della bealerie Coleasque et civitatis Taurini per finanziare la riparazione della fiche Pelerine.
(4.11) Cfr. ad esempio ASCT, CS 1971. Tra le nuove installazioni idrauliche spiccano i “martinetti” per la lavorazione di metalli, spezie e galla da concia (ASCT, CS 1977).
5. Le prime attestazioni documentarie
Le prime testimonianze della bealera Colleasca provengono dagli atti notarili della prima metà del Trecento. Si tralasciano quindi le tracce di elementi idraulici dei secoli precedenti, troppo labili e frammentarie per poter essere utilizzate proficuamente. (5.1) La prima indicazione certa della bealera risale all'11 ottobre 1322, data del rinnovo di un atto del 1311, con cui Filippo d'Acaia concedeva a Bertolino Tintore, «per sé e per i suoi eredi, il ponte sul Po di Torino e le proprietà, i beni, i ricavi, le acque e i corsi d'acqua e tutti i diritti pertinenti a detto Ponte, in qualunque modo e in qualunque cosa consistano, e l'acqua condotta dalla bealera Colleasca, dalla bicocha sino al Po, e per il fossato lungo». Ribadendo la salvaguardia delle prerogative degli altri utenti, l'atto confermava le condizioni precedenti e stabiliva il canone annuo di 30 fiorini «di buon oro» per i sei anni successivi. (5.2)
Bertolino Tintore e i suoi discendenti ricoprirono per quasi un secolo incarichi di primo piano nella cura delle strutture idrauliche. Oltre alla gestione dei ponti e delle attività collegate, e alle concessioni rilasciate in nome del Principe, (5.3) fu affidata loro la supervisione dei mulini e delle macchine idrauliche signorili. Consulenti sulle principali questioni idrauliche, i Tintore ottennero spesso gli appalti di manutenzione da parte della Città, consolidando un quasi monopolio grazie alla professionalità e all'esperienza. Bertolino veniva di volta in volta menzionato con i titoli altisonanti di "Ponterius, "Governatore”, "Custode", "Amministratore", "Rettore", "Ministro" del ponte di Po, ma era innanzitutto un mastro carpentiere specializzato e un imprenditore. La vulnerabilità delle opere idrauliche rese le attività della famiglia particolarmente redditizie, favorendone l’accesso all’oligarchia cittadina e consentendo ad alcuni membri di assumere cariche pubbliche di rilievo. (5.4).
Il tracciato di massima della "bealera Colleasca" — derivata dalla gran ficha sulla Magne Durie nei pressi della bichoca, e diretta verso Torino, confluendo nel Po attraverso il “fossal lungo” — trova riscontro nelle concessioni d'acqua della prima metà del XIV secolo, sintetizzate nella tabella che segue. (Fig. 5.1)
Fig. 5.1 Atti notarili di concessione d’acqua, dal fondo Carte Sciolte dell’Archivio Storico del Comune di Torino. Questi documenti offrono interessanti informazioni sulla gestione delle acque e utili indizi topografici. La tabella riporta solo le pratiche trecentesche, destinate a intensificarsi nel secolo successivo.
Negli Ordinati
Negli Ordinati, le trattazioni di faccende idrauliche sono relativamente più tarde. Prima dell'emanazione degli Statuti del 1360, la Città si occupava soprattutto di risarcire i danni alle proprietà e ripristinare le strade dopo gli straripamenti di canali e bealere dovuti alle forti piogge e alla piena dei fiumi. Altre menzioni emergono dai provvedimenti volti al rafforzamento delle linee di difesa di ampio raggio tracciate intorno a Torino.
La prima questione d’acqua è affrontata fin dal 1325, anno in cui iniziano le pubblicazioni dei verbali. L'11 giugno, infatti, i massari dei ponti, Bertolino Tintore e Bartolomeo Capra, ricevettero l'incarico di riparare le strade danneggiate o distrutte in città e nei borghi dall'impeto di quelle che il documento definisce testualmente aque silicet aqua bealerie, riferendosi con ogni probabilità alla bealera Colleasca. (5.5) Tale nome compare per la prima volta il 1° maggio 1342, nel comando di una royda (corveè) per lavori ad bealeriam Colease (sic) a carico degli ospizi dei quartieri di Porta Pusterla e Porta Nuova. (5.6) Sebbene indicata come bealeram Durie, la sua riparazione era stata deliberata già il 30 aprile precedente, ribadendo al contempo la proibizione di danneggiarla o distruggerne le opere di fortificazione. (5.7) Queste menzioni fanno seguito a quella del 26 agosto 1339, in cui il ponterius Padi Bertolino Tintore richiedeva l'autorizzazione a misurare la bealeria Coleasche e il Fosatum longum per meglio definirne i tracciati. (5.8)
Il nome "Pellerina" — nella forma latina di Pelerine — è annotato per la prima volta nei verbali consigliari il 30 aprile 1342. In quell'occasione la bicocha risulta gravemente danneggiata e se ne dispone la ricostruzione «dove era solita essere», confermando così un'origine precedente. (5.9) L’associazione del toponimo alla bealera Colleasca avviene in ambito militare, nell’ordine impartito il 12 febbraio 1343 ai manovali che lavoravano alla bicocha di chiudere sia il guado della Pellerina (claudendum vada Pelerine) sia il passaggio sulla bealera Colleasca (transitus bealerie Coleasche). (5.10)
La "bealera della porta Segusina" trova la prima menzione negli Ordinati il 23 aprile 1346, nella deliberazione relativa alla costruzione di un nuovo cunicolo, o "acquedotto", che entra nell'abitato in prossimità della porta stessa: cuniculo novo seu acheductu (sic!) que intrat civitatem Taurini iusta portam Secuxine. (5.11)
Le Lettere Patenti del 24 marzo 1360 e gli Statuti della Città
Le Lettere Patenti del 24 marzo e gli Statuti del 6 giugno 1360 del conte di Savoia Amedeo VI segnarono una svolta nella storia di Torino. (a) Ripreso il controllo della città e stroncati i tentativi di indipendenza del cugino Giacomo d'Acaia, con questi atti, il Conte Verde volle premiare l'appoggio ricevuto dai torinesi, concedendo loro autonomie nella gestione dei beni, nella fiscalità e nella difesa del territorio che avrebbero posto le basi di un nuovo ordinamento istituzionale destinato a durare per secoli. In tale contesto, Torino e i suoi cittadini videro confermati i diritti sui corsi d'acqua artificiali, disponendo al contempo i provvedimenti volti a ristrutturare, potenziare le opere esistenti e realizzarne di nuove.
Le Lettere Patenti del 24 marzo 1360
Tra i 34 capitoli del documento, i capitoli XXVI, XXVII, XXIX e XXXII trattano i diritti e i privilegi della Città di Torino sulle acque. Ad essa venne innanzitutto riconfermata in perpetuo la facoltà di disporre e ordinare su fiumi, canali, acquedotti e tutte le acque scorrenti nel territorio — escluse soltanto quelle di pertinenza privata — garantendo a ogni cittadino il libero accesso alle risorse idriche, nel rispetto delle tradizioni locali. (cap. XXVI)
Furono altresì confermati i diritti dei torinesi di proprietà e affitto su canali e bealere e ogni altra risorsa situata nei comuni di Collegno, Alpignano, Pianezza, Druento, Borgaro, Cavoretto, Altessano, Settimo, Gassino e altri centri limitrofi della diocesi. Inoltre, secondo un'antica e consolidata consuetudine, fu proibito alle comunità locali di imporre loro oneri fiscali. (cap. XXVIII) Inoltre, furono confermate le concessioni relative all'uso dell'acqua e degli acquedotti accordate in precedenza dal principe Giacomo d'Acaia e dal padre suo Filippo, ribadendone la necessità del più rigoroso rispetto. (cap. XXIX)
Il documento conferma che a quel tempo il contado era già irrigato da canalizzazioni artificiali, e concedeva ai cittadini torinesi di ampliare il sistema scavandone due nuove. Tuttavia, identificare con certezza queste due bealere risulta difficile, poiché la formulazione del testo è generica, e si limita a indicare che potevano derivare liberamente dalla Dora Riparia nei comuni di Rivoli, Alpignano, Pianezza o Collegno, senza particolari vincoli o oneri per i costruttori, salvo l’obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati. (cap. XXXII) (b)
Gli Statuti della Città di Torino del 6 giugno 1360
I 331 capitoli degli Statuti approvati da Amedeo VI di Savoia con Lettere Patenti del 6 giugno 1360 — su proposta del Maggior Consiglio cittadino — regolamentano i più vari aspetti della vita pubblica e privata. Essi spaziano dai compiti delle autorità di governo e dall'organizzazione dei pubblici uffici, al diritto privato e penale. Le norme dedicate alla "polizia urbana", in particolare, offrono dettagli, a volte curiosi, sulla quotidianità economica e sociale della Torino medievale. (c)
I capitoli LXVIII, CLIV, CXXIV e CCCII sono dedicati alle canalizzazioni artificiali e alla disciplina dei mulini. Essi consolidano il monopolio sull'uso delle risorse idriche e il diritto di banno a favore dei proprietari dei mulini, proibiscono e sanzionano i prelievi illeciti d'acqua, attribuiscono alla Città la sovranità sulla bealera Colleasca, con il compito di ristrutturarla e potenziarla.
Il capitolo LXVIII — "De molandinis non faciendis a deruinata Durie usque ad Padum nec a vado Sancti Viti usque ad podium Miscle" — vieta la costruzione di mulini, gualchiere e folloni sulla Dora fino al Po, e [su quest'ultimo] dal guado di San Vito fino al colle di Miscle, senza il consenso dei "domini molandinorum", ovvero del Principe, del Comune o dei privati proprietari. (c) Anche la ristrutturazione, la riparazione e l'ampliamento degli impianti esistenti vengono subordinati al loro consenso, istituendo di fatto un regime di monopolio. Le regolamentazioni rivolte alle macchine idrauliche utilizzate nella lavorazione del legno, della pelle, della canapa e della lana testimoniano inoltre una qualche meccanizzazione dell’industria torinese. (d)
Simili misure di politica annonaria — tipiche della regolamentazione medievale, volte a limitare la libertà economica — perseguivano un duplice scopo. Da un lato, miravano ad assicurare la produzione di farine e pane anche durante le carestie, contenendo così il malcontento della popolazione per la mancanza di alimenti essenziali. Dall'altro, l'obbligo di banno, oltre a costituire una prerogativa del potere feudale e un vantaggio economico per i proprietari, era indispensabile per garantire il pieno utilizzo e la redditività di impianti altrimenti penalizzati da bassa produttività e ingenti costi di costruzione e manutenzione, legati sia alla necessità di ricorrere ad artigiani altamente specializzati, sia al largo impiego del legno, materiale esposto a rapida usura per l'umidità e i danni causati da eventi naturali avversi.
Il capitolo CLIV — "De aqua bealerie non devianda indebite" — tutela canali e bealere da abusi, deviazioni e prelievi illeciti d’acqua. In particolare, stabilisce che «in nessun caso, nessuno potrà osare di deviare, o far deviare, per sé o per altri, le acque della bealera Coleasca, che scorre dalla 'ficha seu bichocha' sulla Grande Dora fino al Po fuori la città e i sobborghi, o verso il canale della Porta Segusina, come pure l'acqua che fuoriesce dalle mura». Le irrigazioni dovranno rispettare i giorni e le ore stabiliti, «senza che nessuno ponga o crei ostacoli al libero fluire delle acque, cosicché possano giungere interamente alle proprietà a cui sono destinate». Ogni trasgressore «sarà punito con una multa di venti soldi per ogni infrazione commessa di giorno, e del doppio se avvenuta di notte, e sarà costretto a risarcire i danni causati ai legittimi destinatari delle acque». (f)
Il capitolo CXXIV — "De non incidendo in buscho bealis" - proibisce la raccolta della legna e taglio degli alberi lungo i canali. (g)
II capitolo CCCII — "De bealeria qualiter debeata ampliari" — infine, attribuisce al Comune di Torino la sovranità e responsabilità sulla bealera «che scorre liberamente dalla Dora verso Torino», con il mandato di ripristino e riqualificazione. L’alveo e le sponde dovranno essere ispezionati da un gruppo di 'viros probos' nominati dai clavari, con il compito di formulare le adeguate proposte per l'ampliamento, individuando i modi e i luoghi in cui gli argini dovranno essere riportati alle giuste dimensioni, allargati o consolidati. Sulla base delle loro osservazioni, il Consiglio adotterà le misure opportune e provvederà a redigere un regolamento della bealera coerente con il corpus delle norme municipali. (h) Il fatto che un intero capitolo degli Statuti sia dedicato alla bealera ne sottolinea l’importanza, mentre l’elenco degli interventi di cui necessita ne mette in luce il marcato degrado — forse dovuto anche a sovrapposizioni di competenze che l’affidamento all’Amministrazione comunale dovrebbe risolvere.
note __________________________________________
(a) Per le Lettere Patenti del 24 marzo 1360, cfr. F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino all'8 dicembre 1798, Vol. IX, Tomo XI, p. 285-286.
(b) Non sappiamo con certezza se e quando le due bealere furono effettivamente realizzate, né quale nome assunsero. L’indeterminatezza e la brevità del testo hanno offerto a più di un consorzio di gestione l’occasione per citare questo documento come prova dell’antichità e della legittimità dei loro diritti di derivazione
(c) Per il testo integrale latino, cfr. D. Bizzarri, Gli Statuti del comune di Torino del 1360, Torino, 1933. Nel Medioevo, il termine "polizia urbana" aveva un significato ampio, che non comprendeva soltanto il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza, o la pulizia delle strade e lo sgombero dei rifiuti, ma anche un insieme di norme che disciplinavano la quotidianità cittadina, tra cui il controllo dei mercati e delle attività economiche, l'igiene e la salute pubblica e la gestione del territorio.
(d) La 'deruinata Durie' parrebbe ricondurre alla 'deruinata bicocha', a cui si è già accennato. Più chiari sono i riferimenti al guado di San Vito, sul Po, e al colle di Miscle, situato lungo il fiume verso San Mauro. Cfr. D. Bizzarri, Gli Statuti del comune di Torino, cit.
(e) Nell’ambito manifatturiero, come in tutta Europa, le lavorazioni più importanti erano quelle dei panni lana. Gli Statuti dedicano loro due lunghi e dettagliati capitoli, normando la produzione dei “panni di Torino” (CCCXXIII) e punendone severamente la fabbricazione fraudolenta. (XXXVI). Ibidem.
(f) L’infrazione era punita con una multa di cinque soldi per ogni sestario di cereali macinato illecitamente e con la confisca delle farine. Se la violazione fosse stata denunciata sotto giuramento da persona di buona reputazione, a questa sarebbe spettato un terzo della sanzione. Ibidem.
(g) Ibidem.
(h) Ibidem. — Se l’acqua fosse stata deviata illecitamente verso un terreno in orari non autorizzati, il proprietario ne sarebbe stato ritenuto responsabile, salvo giurasse sulla Sacra Bibbia la propria innocenza e indicasse, se ne era a conoscenza, il colpevole. La denuncia sotto giuramento di una persona di buona fama non richiedeva ulteriori prove.
(h) I clavari (o chiavari) erano ufficiali comunali incaricati della gestione finanziaria e amministrativa. In pratica, fungevano da tesorieri del Comune, figure di fiducia responsabili della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni, nonché della supervisione delle infrastrutture, occupando quindi ruoli fondamentali nell’attuazione delle politiche locali.
L'articolo ribadisce il diritto di banno, conferendo ai molini cittadini l’esclusiva sulla molitura di grani e legumi. I torinesi venivano così obbligati a servirsi esclusivamente di questi impianti, pena pesanti multe e la confisca dei cereali e del macinato per chi fosse scoperto a recarsi altrove. (e) La misura penalizzava gli abitanti delle campagne più lontane, come il Lingotto o Millefonti, costringendoli ad affrontare lunghi tragitti per raggiungere gli impianti di Porta Palazzo e, giunti in loco, a sopportare lunghe attese. L'alternativa era un doppio viaggio di andata e ritorno, mentre senza tale imposizione avrebbero potuto usufruire con maggiore comodità e risparmio di tempo dei palmenti dei comuni limitrofi. Infine, veniva fissato un compenso massimo per i mugnai — pari alla sedicesima parte delle farine prodotte — per tutelare i consumatori e proteggerli da abusi e richieste troppo esose.
note 5 __________________________________________
(5.1) Cfr. A Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit.p. 814.
(5.2) Più precisamente: et aquam que dicitur per bealeriam Coleasche, a Bicocha usque in Padum et per Fossatum lungum, cfr. ASCT, CS 1870). Il documento del 6 agosto 1311 non è reperibile.
(5.3) La compravendita delle ore d’acqua tra privati venivano formalmente ratificate dal Principe, al quale tuttavia non fruttavano solitamente che qualche emina di grano o avena.
(5.4) Cfr. A. Barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Viella, 1995, pp.
(5.5) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. 1, p. 39-40.
(5.6) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. III, p. 26.
(5.7) Ibidem, p. 11.
(5.8) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. II, p. 220.
(5.9) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. III, p. 24.
(5.10) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. III, p. 97.
(5.11) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. III, p. 171 e 176. La deliberazione riguarda anche la sistemazione di ponti e strade nei pressi della porta stessa. Tuttavia, il 6 giugno il nuovo manufatto sarà abbandonato e le acque reindirizzate nel vecchio alveo a causa del malfunzionamento e dei danni provocati alle proprietà circostanti.
6. Il passaggio della bealera alla Città (*)
L'avvio del processo
Il trasferimento delle competenze sulla bealera Colleasca è documentato negli Ordinati a partire dal 1365, dopo la lunga interruzione della serie iniziata nel 1354. Il processo, in conformità con i recenti Statuti, si colloca nel contesto delle trattative con il principe Giacomo d'Acaia — nel frattempo reintegrato dal cugino nella sovranità e nei possedimenti — per la cessione al Comune delle gabelle e delle entrate fiscali in precedenza riscosse in suo nome.
Il 24 febbraio 1366, il ripristino della bealera e la definizione del quadro normativo vengono affidati a otto sapientes (viros probos, o "saggi"), a cui l’8 marzo se ne aggiungono altri otto con responsabilità sui ponti. Come già accennato, la canalizzazione versa in condizioni precarie e richiede molteplici interventi. Il primo provvedimento, datato 3 marzo, riguarda il rifacimento e l'innalzamento della ficham bealeria Coleasche — definita anche ficham bichoque — per aumentare l'acqua introdotta. Per finanziare i lavori, si delibera il recupero «senza indugio» dei fitti arretrati non riscossi dai pontieri negli ultimi tre anni, mentre i proprietari dei prati «che già pagano un canone d’acqua» sono tassati dodici denari per ogni giornata di terra. Altri provvedimenti riguardano il compenso dei mastri carpentieri impegnati nel cantiere della ficca, fissato in sei soldi al giorno, e il richiamo al rispetto delle norme, intimando ai titolari di non alzare le paratoie delle prese irrigue oltre il consentito. In via provvisoria, su suggerimento dei sapientes incaricati di formulare una proposta 'ragionevole', il 18 marzo il Consiglio porta la tassazione per l'uso dell'acqua a tre soldi viennesi, ovvero a 36 denari, per giornata di prato irrigato, «salvo dichiarazione giurata di possederne meno».
Il quadro amministrativo e le responsabilità di gestione
Sentite le proposte dei saggi e ottenuto il consenso del Principe, il 10 maggio 1366, il Consiglio nomina i responsabili e approva le regole per la gestione delle acque. Nel nuovo assetto amministrativo, ai cittadini torinesi Antonietto Beccuti e Tommaso de Pertusio è affidato l'incarico di massari dei ponti. Il mandato, di durata triennale, prevede il censimento e l'affitto di proprietà, prati, vigneti e ogni altro bene pertinente ad essi, oltre all'accertamento delle entrate e di ogni privilegio spettante di diritto. La manutenzione e le riparazioni delle opere idrauliche sono assegnate ai mastri Giovanni de Castellono e Martino Tintore, stabilendo retribuzioni e penali per le inadempienze. Bartolomeo Borgesio, Oberto de Gorzano e il Comes Becutus sono designati massari «dell'acquedotto della città di Torino, dalla Pellerina fino al fiume Po».
I loro compiti corrispondono in buona parte al regolamento della bealera e comprendono:
-
L'ispezione e la cura delle sponde, vigilando affinché i proprietari provvedano a proprie spese alla riparazione delle prese e degli aquayrolij (i fossi) di loro pertinenza. Qualora i danneggiamenti siano attribuibili a terzi, l'onere del ripristino ricadrà su di essi. Ogni violazione delle disposizioni impartite dai massari prevede l'ammenda di dieci lire.
-
La verifica e l'approvazione delle dimensioni e della conformità dei bocchetti irrigui, che in linea generale non dovranno incidere le due sponde della bealera (superiore e inferiore) per una profondità maggiore di due piedi dal fondo.
A chiunque viene, inoltre, tassativamente proibito:
-
Di porre, o far porre, trasversalmente sul fondo della bealera materiali di qualsiasi tipo che possano ostacolare indebitamente, in tutto o in parte, lo scorrere delle acque, sotto pena di cento soldi di ammenda per ogni infrazione.
-
Di collocare, o far collocare, ostacoli quali legni, pietre, terra o altri materiali nei condotti interni all'abitato, al fine di deviarne anche solo parzialmente i flussi, salvo quando richiesto dalle irrigazioni. Ognuna di queste violazione comporta una pena di venti soldi.
La Città di Torino acquisisce così il controllo sull’intero sistema idraulico, dalla gestione delle acque discorrenti sul territorio — fatta eccezione per quelle di pertinenza privata o del Principe — alle opere di presa, ai ponti e alle sponde dei fiumi. Il processo si concluderà con la riconsegna, alla naturale scadenza e nelle mani del massaro, di ogni titolo di concessione precedentemente accordato dai Conti di Savoia, dal Principe d’Acaia o, in suo nome, dal ponterius Padi.
Le responsabilità di gestione
La supervisione del sistema era di competenza del massario comunis, mentre la cura delle singole strutture — la bealera, la traversa e i ponti — erano assegnate a massari designati, solitamente due nel caso della ficca Pellerina. I loro incarichi erano di lunga durata e riguardavano la manutenzione ordinaria, con il controllo degli alvei e la conservazione dell’integrità e dell’altezza delle sponde della bealera, mentre gli interventi straordinari e le riparazioni più impegnative richiedevano autorizzazioni specifiche. Ogni violazione delle disposizioni di questi ufficiali era punita con ammende da riscuotere immediatamente, senza deroghe né eccezioni. (6.1)
Rientravano tra i compiti del massaro del comune le ispezioni — da effettuare ogni quindici giorni, di persona o tramite un delegato di fiducia — alle principali strutture: la ficca Pellerina, l’alveo della bealera e con i relativi scaricatori, i ponti sul Po e sulla Dora. Erano inoltre di sua responsabilità la riscossione dei fitti della bealera e degli eventuali arretrati, il controllo sulle operazioni di ripristino, l'assunzione di lavoratori e bovari, l'approvvigionamento della legna e dei materiali necessari. Egli poteva autorizzare le riparazioni fino a dieci lire di spesa, mentre i provvedimenti più costosi dovevano essere approvati dal Consiglio. (6.2)
Illeciti, abusi e limiti dell'Amministrazione
I conflitti dovuti all’uso delle acque erano frequenti. Cedimenti e rotture degli argini e distruzioni degli alvei non erano solo effetto di eventi naturali, ma spesso intenzionali. Tra le diverse cause dei danneggiamenti vi erano i contrasti tra interessi pubblici e privati, quelli tra particolari, l’ostilità dei contadini verso l’espansione dei prati e soprattutto l’apertura di prese non autorizzate e i prelievi d’acqua abusivi, che nemmeno le sanzioni riuscivano a impedire. Inevitabilmente, questi fenomeni minavano l’autorità e le prerogative della Città sulle acque, talora insidiate perfino dalle pretese del Principe.
Né i suoi poteri effettivi erano rafforzati da una gestione amministrativa del sistema idraulico improntata al pragmatismo, peraltro coerente con le possibilità teoriche e pratiche medievali e con le necessità dil limitato numero di prese irrigue e di adempimenti collegati. Un’organizzazione più articolata degli uffici e una burocrazia intermedia, comunque a quel tempo premature, avrebbero potuto migliorare l’efficienza, collocandosi tra i responsabili tecnici delle opere idrauliche — cui spettavano compiti perlopiù esecutivi — e il massaro, la cui azione risultava indebolita anche dall’assenza di forze di polizia alle sue dirette dipendenze per dare esecuzione agli ordini. A ciò si aggiungeva la brevità del mandato, che non favoriva il pieno espletamento dei compiti né assicurava continuità alla funzione.
In tale quadro, veniva a mancare una sicura percezione dello spazio amministrato. Non a caso, in assenza di documentazione cartografica, ogni intervento era preceduto da ispezioni in loco per verificare l’accaduto e decidere il da farsi. Di fatto, si interveniva concretamente solo quando la funzionalità del sistema risultava gravemente compromessa, ad esempio perché l’acqua non riusciva più a raggiungere l'abitato. Solo allora si intimava «di far chiudere e interrare le prese e i fossi indebitamente realizzati e rimuovere gli sbarramenti che deviavano indebitamente l’acqua», di provvedere alla riparazione della bealera, di indagare chi avesse «innovato qualcosa contro il diritto nella suddetta bealera, a suo detrimento, e di coloro che hanno il diritto di condurre tale acqua, e punire immediatamente i colpevoli»un .
Ingiunzioni di ripristino e punizioni non riuscivano a impedire che gli illeciti si cristallizzassero in situazioni di fatto compromettendo il quadro legale e l’interesse collettivo. Per riportare ordine e giustizia, il Consiglio era allora costretto a censire e verificare la liceità delle prese irrigue, imponendo di esibire i titoli di concessione. Come si evince dalla deliberazione del 3 aprile 1373, in simili frangenti «chiunque avesse, o pretendesse di avere, diritti sull'acqua, o sulla bealera della Dora, dalla bichoca Pellerine al Po» era tenuto a consegnare al massaro e a un notaio della Curia «documenti, testimonianze o altre prove legittime entro il quindicesimo giorno del mese». Chi non li avesse presentati perdeva ogni diritto all’uso dell’acqua e subiva una multa di «venti soldi d’ammenda per ogni giorno di irrigazione non autorizzato successivo a tale data».
Le sanzioni
Colpevoli e inadempienti erano puniti con pene pecuniarie, e solo raramente con sanzioni più severe, come il sequestro dei beni e l'arresto. Pene corporali, quali la fustigazione e la pubblica gogna, erano inflitte a chi si rifiutava di pagare o per azioni particolarmente gravi. I responsabili di fatti dolosi erano obbligati a provvedere immediatamente e a proprie spese alle riparazioni, un obbligo peraltro valido per qualsiasi danneggiamento volontario di beni pubblici. La riscossione delle ammende era in genere immediata e non contemplava possibilità di appello. La delazione era incoraggiata, tanto che la semplice testimonianza giurata di un «qualsiasi uomo di buona fama» era di norma sufficiente e premiata con la terza parte dell'ammenda.
I provvedimenti potevano riflettere le differenti prerogative dei laici e del clero. Ad esempio, il 2 maggio 1388, nella sentenza definitiva di una controversia tra la Città e gli Umiliati del convento di San Cristoforo, il Giudice ordinava la chiusura di due bocchetti della bealera Colleasca utilizzati dai frati, specificando che «chiunque, di qualunque condizione, purché laica, avesse osato riaprirli, o farli riaprire senza l’autorizzazione del Consiglio» sarebbe incorso in un'ammenda di cento soldi viennesi, restando però incerto se la stessa misura venisse applicata anche a un ecclesiastico. Le eventuali irrigazioni effettuate dai debitori diventavano illegali e punite, anche più volte, fino all'estinzione del debito. L'estensione delle sanzioni a chi lavorava i prati dei renitenti e il consentire a chiunque di raccogliervi liberamente erba e fieno o di farvi pascolare il bestiame rappresentavano possibili pene accessorie e forme di deterrenza.
Tuttavia, il Consiglio non mostrava intenti persecutori e talora si rendeva disponibile a trovare accomodamenti e regolarizzare le situazioni di fatto, forse in ragione della comune appartenenza alla ristretta cerchia di maggiorenti di amministratori e proprietari. In questo senso può essere interpretata la raccomandazione del 27 marzo 1374, secondo cui «l’acqua indebitamente usata da chi non è in grado di dimostrare in modo adeguato l’investitura per l’uso, potrà essere concessa ad altri per una durata massima di ventinove anni, dando tuttavia la preferenza a chi già detiene tale acqua rispetto ad altri che desiderino prenderla in affitto». (Ovviamente, dopo aver regolarizzato la propria situazione). Analogamente, il 31 dicembre 1387, ai massari incaricati di individuare e perseguire chi avesse tagliato e si fosse indebitamente appropriato di alcuni alberi lungo la bealera fu raccomandato «di procedere con leggerezza» se il colpevole avesse dimostrato la volontà di trovare un accordo.
Rimane comunque l'impressione che i membri del Consiglio, gli ufficiali di rango elevato rispondessero a un’etica dettata dalla forte consapevolezza del ruolo, per la quale l’interesse collettivo si imponeva sul particolare. Così, ad esempio, già una delle primissime concessioni irrigue a noi note — quella rilasciata il 21 giugno 1321 dal ponterius Padi a Francesco Borgesio (fig. 5.1) — era strettamente vincolata alla clausola per cui «l'acqua stessa scorresse abbondantemente e continuasse a scorrere abbondantemente attraverso la detta bealera verso la città di Torino»; una condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione e un principio di priorità destinato a rimanere parte integrante di ogni contratto, concessione e autorizzazione rilasciata nei secoli successivi.
Gli interventi sulla bealera
La piena efficienza del sistema idraulico, per sua natura vulnerabile, dipendeva dalla puntuale esecuzione degli interventi conservativi, in mancanza dei quali la funzionalità si deteriorava rapidamente. Le riparazioni erano quindi molto più frequenti delle costruzioni ex novo. I nuovi scavi riguardavano soprattutto la realizzazione di condotti scaricatori o lo spostamento degli alvei, quando altre soluzioni non erano possibili. I lavori strutturali volti ad aumentare la capacità di derivazione erano più rari, anche perché la sola conservazione del sistema assorbiva considerevoli risorse. (6.3) D’altra parte, le competenze del Comune si limitavano alle acque strettamente “torinesi”, mentre l’apertura di nuove canalizzazioni rimaneva subordinata alle concessioni ducali e alla volontà degli interessati. La manutenzione degli alvei principali, periodica e straordinaria, spettava alla Città, mentre la cura dei bocchetti, delle paratoie e dei fossi irrigui era demandata ai privati.
Rami, tronchi, detriti e ogni altro ostacolo doveva essere prontamente rimosso per consentire il libero fluire delle acque. Per prevenire gli interramenti e ridurre il rischio di esondazione, era fondamentale conservare l'integrità e l'altezza delle sponde e la corretta sezione degli alvei, asportando gli abbondanti sedimenti depositati dalle acque limacciose della Dora. Questi Lavori erano molto impegnativi e potevano richiedere un gran numero di manovali, reclutati spesso tramite corveé. (6.4)

Fig. 6.1 La pulizia degli alvei, la rimozione dei depositi sabbiosi e il ripristino della altezza delle sponde volte mantenere la corretta sezione restano indispensabili per prevenire gli straripamenti.
Bealera dei prati di Pianezza - Pianezza, 17-01-2025
I verbali consigliari riportano spesso la notizia che la ripa bealerie Pelerine fracta sive diruta est, ma l'elemento più vulnerabile era la ficca — un semplice allineamento pali di rovere "conficcati" nel letto del fiume, rinforzato con ramaglie, fascine, tavole e pietre — che a stento era in grado di contenere l’impeto delle acque. (v. scheda) Gli interventi di ripristino erano scanditi dalle alluvioni e dalle piene del fiume che si ripetevano con frequenza pressoché annuale: talvolta era sufficiente soltanto aggiungere o sostituire qualche elemento danneggiato o trascinato via dalla corrente; altre volte occorreva un rifacimento parziale e, nei casi più gravi, la ricostruzione.
La frequenza delle riparazioni dopo il passaggio della bealera alla Città risulta sensibilmente maggiore rispetto al periodo della gestione ducale. Non è facile stabilire in quale misura ciò dipenda dalla maggior disponibilità di documenti, dalla più complessa articolazione delle strutture o dal venir meno dell’optimum climatico medievale, che nei due secoli precedenti aveva garantito precipitazioni più regolari e meno intense, riducendo la frequenza e l’impatto delle alluvioni.
Nel corso del XIV secolo, gli eventi naturali ebbero talora effetti molto gravi sul sistema idraulico, con episodi particolarmente distruttivi tra la fine del secolo e l’inizio di quello successivo. Verso la fine del Trecento, un’esondazione della Dora distrusse l’imbocco del canale dei mulini, danneggiando così gravemente gli impianti di Porta Palazzo da renderli inattivi fino alla completa ricostruzione. (6.5) Nel 1408 il baptitorium papiri a una ruota per la produzione della carta, da poco installato da Giovanni Cornaglia sullo stesso canale, fu rovinato da un’inondazione senza possibilità di ripristino, poiché la forza delle acque aveva talmente abbassato il fondo della bealera da renderne insostenibile il costo. (6.6)
Fiche et fichayroni
Problematiche simili non risparmiavano i fichayroni, termine inusuale, che per analogia, sembra riferito alle lunghe palizzate in legno messe in opera per proteggere dall'erosione le sponde fluviali o le spalle dei ponti, come nel caso del fichayronum existentem desuper magnum ponte Durie. (6.7) Tuttavia, fiche et ficheroni, non erano minacciati soltanto dal maltempo, ma anche dai furti dei torinesi, i quali non sembravano farsi scrupolo di appropriarsi di rami e ramaglie già tagliati e ben accatastati in fascine. Lo testimonia l'ordine perentorio del Consiglio del 1 maggio 1385 — giustificato forse dallo stato di guerra del momento — secondo cui «nessuna persona, di qualunque luogo o di qualunque condizione sociale, osi prendere, o asportare, pali o ramaglie, sia dai fichayronis esistenti, sia da quelli che saranno eretti in futuro lungo la Dora», minacciando una multa di dieci soldi viennesi per ogni appropriazione, e la fustigazione o la messa alla berlina di chi si rifiutasse di pagarla.
La tutela dei ponti richiedeva il controllo di tronchi e detriti trasportati dalle alluvioni, che ne minacciavano la stabilità. Così, il 7 giugno 1390 Martino Tintore, insieme a un notaio e un camparo, venne incaricato di percorrere le rive del Po e della Dora a monte dei ponti per individuare e marcare «alberi e alberelli pericolanti», che dopo le passate inondazioni rischiavano di cadere in acqua. I proprietari, una volta individuati, venivano sollecitati a tagliarli, o farli tagliare, entro il prossimo San Michele, facendone fascine o ad allontanarli entro tre giorni dalle rive. Un analogo provvedimento è documentato dalla disposizione del 26 settembre 1391 per il «disboscamento del ponte di Po», ossia la rimozione del legname ammassato contro i piloni, un problema tuttora attuale.
Le procedure di ripristino
Il ripristino delle opere danneggiate seguiva un iter scandito in ogni suo passo dalle deliberazioni consigliari. I Clavari provvedevano innanzitutto a formare la commissione incaricata del caso, composta dal massaro e da un certo numero di sapientes, in genere da quattro a otto per garantire pluralità e competenza, di norma dispari per consentire decisioni a maggioranza in caso di pareri discordi. Il potere conferito loro era massimo e ogni decisione, assunta all’unanimità o a maggioranza, aveva identico valore di un ordine del Consiglio.
La commissione si recava quindi in loco per accertare l'accaduto, valutare il tipo e l'entità dei danni e stabilire gli interventi necessari, «giurando sui santi vangeli di Dio la loro buona fede». I lavori erano affidati a mastri e operai specializzati, ricorrendo spesso a prestazioni lavorative obbligatorie (royde) per la manovalanza e i trasporti. Il pagamento era deliberato solo dopo la verifica della bontà e della conformità di quanto eseguito. In caso di dolo, il massaro e i sapientes avevano il potere di punire i responsabili e addebitare loro i costi.
Anziché in denaro, gli interventi sui ponti minori potevano essere ricompensati con l'esenzione di alcuni obblighi civici, come il servizio di guardia. Ad esempio, il 23 maggio 1378 Pietro de Burgo, ottenne, su sua esplicita richiesta, l'esonero perpetuo dalla guardia cittadina notturna, in cambio della ricostruzione e della manutenzione del «ponte di Colleasche, fatta con coscienza e con adeguati accessi da entrambi i lati» — incarico già proposto il 2 aprile dell'anno precedente a Giacobino Adornato alle stesse condizioni. Ugualmente, il 14 agosto 1379 Bertino Brusati e il figlio Antonio furono esentati dalla custodia notturna e diurna e dalle guardie, a condizione di mantenere in buono stato «il ponte sopra il canale della porta Segusina con le spallette rialzate da entrambe le parti del ponte, e ciò in perpetuo finché vivranno».
Costi e finanziamenti
La conservazione e la funzionalità delle infrastrutture idrauliche non dipendevano da difficoltà tecniche o pratiche, quanto dalla precarietà delle risorse finanziarie disponibili. La prevedibilità delle entrate e delle uscite comunali era infatti limitata. La fiscalità ordinaria poteva contare sul gettito stimabile degli appalti di beni comunali — come le entrate dei mulini — e sulle gabelle su sale, grano, vino, carne e panni, e sui pedaggi dei ponti. Alcune spese, come le paghe del massaro e del maestro di scuola, potevano essere programmate, ma molte altre restavano imprevedibili, a partire dalle spese per la manutenzione di strade, fortificazioni e corsi d’acqua naturali e artificiali. Ancora più aleatori, nei tempi e negli importi, erano i fondi necessari per soddisfare richieste e patti imposti dal Principe, spesso dettati da imponderabili esigenze politiche e militari. Le casse municipali, inoltre, dovevano farsi carico dei risarcimenti, quando i danni indiretti causati del sistema idraulico non fossero imputabili a dolo o colpa di qualcuno, o qualora i responsabili non fossero stati individuati.
L’instabilità dei conti, aggravata dall'assenza di pratiche contabili e strumenti previsionali di bilancio, impediva qualsiasi forma di pianificazione. L'erario comunale si reggeva perciò sull'emergenza e sul continuo ricorso al credito per sostenere la vita cittadina, mentre la finanza straordinaria finiva per prevalere su quella ordinaria. (6.8) Il principale strumento era il prestito forzoso, accompagnato da altre misure complementari, prima fra tutte il recupero di «rendite, fitti e censi» della bealera arretrati o evasi. Il massaro era autorizzato a riscuoterli nei modi più efficaci (solvendum ficta predicta modo forciori quod cogi poterunt) anticipando di tasca propria il denaro qualora non vi fosse riuscito. Morosi e inadempienti erano soggetti a sanzioni, che potevano giungere al sequestro dei beni e all’arresto per chi non versasse il dovutoin tempi brevissimi (es. entro sei giorni, Ordinati, 22 ottobre 1390). I massari potevano essere autorizzati ad attingere direttamente al gettito delle gabelle e dei molini (denari molendinorum). Così, il 17 marzo 1387 il Consiglio ordinava la consegna di 24 lire viennesi dall'appaltatore della gabella «del grano e del vino forestiero» per la riparazione della ficca Pelerina, da integrare, se necessario, con un prestito obbligatorio fino a 20 fiorini imposto agli utilizzatori della bealera.
Il tributo consisteva per lo più nell'anticipo dei canoni d'acqua rispetto alla scadenza naturale, ma poteva anche assumere la forma di una talea, ossia di un prelievo una tantum. Con l'approvazione del Giudice e del Vicario, i Clavari stabilivano il tipo, le modalità e l'importo totale, delegandone la riscossione ai sapientes responsabili dei cantieri. La tassazione aveva un limite massimo prefissato, sia complessivo che per ogni contribuente, ma poteva essere aumentata o ripetuta fino a coprire il fabbisogno. Le somme anticipate erano garantite dalle entrate dei molini e del ponte di Po e venivano remunerate con un interesse (ad esempio, pari a un grosso per fiorino nella deliberazione del 1° giugno 1373 e a 2 soldi viennesi in quella del 17 marzo 1387). Il rimborso avveniva tramite lo sconto sul primo pagamento utile di canoni e affitti. È interessante notare come le deliberazioni consigliari sottolineassero sempre che il denaro raccolto dovesse essere destinato alle riparazioni idrauliche, «e non ad altro».
Gli interventi potevano coinvolgere, talora obtorto collo, i privati. Ne costituisce esempio la deliberazione del 1° dicembre 1374, con cui il Consiglio dava mandato di acquistare i terreni per allontanare l'alveo della bealera dalla strada Colleasca, tassando gli utenti fino a un massimo di 12 denari per giornata, delegando poi l'onere dello scavo del nuovo tracciato ai proprietari dei fondi toccati. Più pacificamente, il 13 marzo 1384 si deliberava la ripartizione dei costi della riparazione del «cunicolo della porta Fibellona» tra la Città e i possessori dell’acqua che vi defluiva. L'Amministrazione aveva anche la facoltà di autorizzare l’esproprio, come ad esempio avvenne il 29 luglio 1383, quando fu permesso al massaro di prelevare il legname necessario per la riparazione della ficca «dai boschi delle chiese ... senza incorrere in pene o bandi».
Le royde
Per i lavori pubblici il Comune ricorreva di frequente alle royde, prestazioni di lavoro obbligatorie richieste ai proprietari di animali da trasporto e alla manovalanza non specializzata. Erano utilizzate per scavi e manutenzioni, nonché per la costruzione e la riparazione di infrastrutture collettive quali ponti, strade e fortificazioni. Le mobilitazioni erano disposte dal Consiglio e organizzate dai massari: bovari e mulattieri si occupavano dei trasporti, mentre nei cantieri i lavoranti generici affiancavano i mastri e gli operai specializzati. (6.10)
Solitamente si svolgevano nei giorni festivi, proseguendo, se necessario, in quelli seguenti. Potevano riguardare l'intera popolazione o solo una parte: l’ordine del 29 marzo 1372, ad esempio, comandava agli abitanti di tre quartieri la pulizia e il disboscamento della bealera della Pellerina, assegnando al quarto la manutenzione della «via verso la Dora». Il 25 marzo 1392, per il ripristino di strade e ponti, erano invece chiamati i possessori di buoi delle sole porte Nuova e Pusterla. Le convocazioni richiedevano in genere la partecipazione di un gavatore (sterratore) per famiglia, munito degli attrezzi adeguati, con la sola eccezione di «vedove, bambini e miserabili». L'obbligo era ineludibile e le pene pecuniarie non esentavano gli inadempienti dal presentarsi al lavoro il giorno successivo.
Le royde erano considerate un dovere civico e pertanto gratuite o remunerate con importi inferiori a quelli usuali. Di fatto, costituivano una forma di tassazione basata su una prestazione obbligatoria, di certo poco gradita. Sia la paga ritenuta troppo bassa — probabilmente calcolata solo in ragione della manutenzione di carri e animali — sia la natura coercitiva del lavoro generavano resistenze, soprattutto tra i bovari. (6.11) L’insofferenza era ancora più accentuata dalla prassi di dilazionare il pagamento, scontandolo alla prima scadenza fiscale.
Un chiaro indicatore di questo malcontento è l’impegno del Consiglio, dichiarato nella riunione del 13 gennaio 1383, a proteggere fisicamente e legalmente «da qualsiasi danno e ingiuria» i massari incaricati di procurare il legname per la riparazione della ficca della Pellerina e del ponte sul Po, organizzandone il trasporto con una royda rivolta alle famiglie dei bovari, ciascuna tenuta a fornire un uomo e remunerata con otto soldi viennesi da scontare sulla prima talea. Anche la progressione delle ammende (due soldi alla prima infrazione e cinque alla seconda) testimonia resistenze diffuse. Allo stesso modo, deve essere interpretato l'ordine del 30 marzo 1376 di individuare e costringere «a portare rami o terra come gli altri, sotto pena di cinque soldi di multa», coloro che, non avendo partecipato alla royda del 17 del mese, avevano impedito il completamento dei lavori alla strada del ponte della Porta Segusina.
Una riparazione della 'ficam Pelerine' (1388)
-
8 giugno 1388: il Consiglio affronta il problema di reperire dei fondi per la riparazione della ficca della Pellerina, a poco più di un anno dall'ultimo intervento. Come di consueto, viene deliberato un prestito forzoso, ordinando che:
-
Quattro uomini designati dai Clavari per comprovata integrità (probi viri) censiscano i prati e gli orti irrigati dalla bealera Pellerina, «dal luogo di presa fino al Po», registrando i nomi e le giornate di terra possedute o utilizzate da ognuno, compresi gli ecclesiastici;
-
Ciascuno versi al massaro quattro soldi per giornata di terra: la metà entro il prossimo giovedì e il resto entro la domenica. Chi si rifiutasse incorrerà nell'ammenda di un grosso. Se il rifiuto persistesse si procederà all'arresto e il rilascio potrà avvenire soltanto dopo il pagamento del dovuto, maggiorato di un ulteriore mezzo grosso. Il prestito sarà rimborsato per compensazione al versamento della prima talea;
-
I bovari torinesi si mettano a disposizione per i trasporti, ricevendo dodici soldi viennesi per ogni coppia di buoi impegnata, da scontarsi alla prima scadenza fiscale;
-
Jacobino Baynerio è nominato massaro e sovrintendente dei lavori, incarico per cui i racionatores (ragionieri) del Comune gli riconosceranno un compenso.
-
-
10 giugno: si definiscono i dettagli della royda, che:
-
Riguarderà tutti i proprietari di buoi di Torino; avrà inizio il giorno seguente e proseguirà nei giorni successivi, festivi o feriali, secondo le disposizioni del massaro.
-
Viene confermato il compenso di dodici soldi da detrarre dalla prima talea. Chi non si presenterà sarà multato di cinque soldi, da riscuotersi immediatamente, con l'obbligo di effettuare il trasporto il giorno successivo.
-
I 'boni viri' Stefano Borgesio e Mallanino Gastaldo sono incaricati di compilare due copie della lista dei bovari, da consegnare una al massaro del comune e l’altra al sovrintendente Jacobino Baynerio.
-
-
17 giugno: il Consiglio delibera ulteriori finanziamenti, stabilendo che:
-
Entro la prossima domenica gli affittuari dell'acqua della bealera Colleasca dovranno anticipare i canoni dovuti alla scadenza di San Martino, sotto pena di cinque soldi viennesi;
-
I versamenti avverranno direttamente nelle mani del massaro e saranno destinati tassativamente alla riparazione della ficca Pellerina;
-
Per assicurare la puntuale esecuzione dell'ordine, le ammende saranno ripartite tra la famiglia del Vicario e gli ufficiali incaricati della riscossione.
-
-
23 giugno: i lavori si confermano più impegnativi del previsto e si ordinano una nuova royda e un nuovo prestito, pertanto:
-
I massari del comune, affiancati da Rainero Becuto e Jacobino Baynerio, dovranno reclutare dodici coppie di buoi per ogni quartiere [per un totale di ben quarantotto coppie e novantasei animali] per condurre pali, ramaglie, pietre e ogni altro materiale al cantiere;
-
Il trasporto dei pali sarà remunerato in ragione di ventiquattro soldi per carro, quello di ramaglie e pietre con venti soldi. La royda delle ramaglie si protrarrà finché il massaro della ficca lo riterrà necessario. Le sanzioni vengono confermate;
-
Il prestito graverà sugli stessi soggetti del precedente, i quali entro la prossima domenica dovranno versare altri 2 soldi per giornata di terra, sotto le penalità già stabilite;
-
I renitenti saranno puniti con sessanta soldi di multa per ogni irrigazione fatta con l’acqua della bealera; la pena è estesa a chiunque ne lavori i prati tagliando l'erba, raccogliendo il fieno o usandola per irrigare;
-
«Fatte grida nella piazza del mercato e altrove di quanto sopra», ogni persona onesta potrà denunciare le infrazioni, e la sua parola sarà creduta sotto semplice giuramento. La pena sarà applicata immediatamente, senza condanna formale, concedendo al debitore tre giorni per la propria difesa. Il denaro riscosso andrà per un terzo all'accusatore, un terzo al Principe e un terzo al Comune.
-
-
9 agosto: il Comune dà mandato di pagare mastri e lavoranti. Tuttavia, il 24 agosto la questione di fondi non pare ancora risolta, e il 6 settembre non tutti sono stati saldati.
-
12 marzo 1389: «Fiche Pelerine et figayroni existentis prope pontem Durie» richiedono nuovi interventi.
note 6 __________________________________________
(*) L’impianto giuridico e la gestione amministrativa delle opere idrauliche che emergono dall’analisi degli Ordinati trecenteschi del Maggior Consiglio rivelano una certa coerenza e uniformità nel tempo. Tuttavia, è necessario sottolineare che, sebbene la struttura generale tenda alla ripetitività, i dettagli delle singole delibere delineano un quadro normativo più complesso, in cui obblighi, divieti, sanzioni, fiscalità e ordini operativi mostrano eterogeneità e flessibilità. Pertanto, quanto qui delineato rappresenta una sintesi generale in cui regole e parametri non sono rigidi né di applicazione uniforme, rispetto ai quali eccezioni e varianti non devono sorprendere. Salvo diversa indicazione, le citazioni identificate con la sola data sono da ritenersi tratte dai Libri Consiliorum, ovvero dalle trascrizioni degli Ordinati trecenteschi della Città di Torino.
(6.1) Il rinnovo dell’incarico di massari della bealera, l’8 luglio 1388, stabiliva che Martino Croseto (o de Crossetis) e i suoi fratelli — già nominati il 10 novembre 1383 — dovessero rimuovere, o far rimuovere, entro tre giorni gli impedimenti indebitamente collocati sulla bealera, sotto pena di essere sottoposti, senza deroga alcuna, alla stessa sanzione prevista per i trasgressori.
(6.2) Il massaro del Comune era responsabile e custode delle casse comunali, incaricato delle riscossioni, della tenuta dei registri e della rendicontazione fiscale periodica. Oltre al controllo scrupoloso di entrate e uscite, rientravano tra le sue mansioni la registrazione dei nuovi residenti e l'inventario dei beni mobili del Comune. Rimaneva in carica per un anno e rispondeva direttamente al Consiglio del proprio operato. Per maggiori dettagli su tali compiti, si rinvia alla deliberazione del 25 giugno 1374 e quella senza data del 1389.
(6.3) Tuttavia, l’11 marzo 1372 viene approvato l’ampliamento della bealera, «attraverso la quale l’acqua scorre dalla derivazione di Pellerina, affinché continui a defluire abbondantemente verso la città e altri luoghi».
(6.4) Ad esempio, il 23 gennaio 1385 il Consiglio ordinava che per la pulizia della bealera municipale fossero messi a disposizione del massaro fino a 45 uomini, retribuiti dal Comune stesso.
(6.5) Cfr. R. Comba, L'economia, in: Storia di Torino Einaudi, vol. II, cit. p. 144.
(6.6) Ivi, p. 149-150.
(6.7) Si veda, ad esempio, la verbalizzazione del 7 giugno 1390, in cui si ripartiscono con il signor Ribaldino Beccuti le spese per riparare i suoi fichayronum, che rischiano di crollare minacciando la strada che conduce al ponte sulla Dora.
(6.8) Cfr. G. Bracco, Le finanze del comune di Torino nel secolo XIV, in "Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento", Torino 1981, e M. Gravela, Comprare il debito della città. Élite politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo, in: Quaderni Storici n°3, dicembre 2014.
(6.9) La "taglia", o talea, era un'imposta diretta inflitta ai governati dal Duca, da un Signore feudale o dal Comune. Era una forma di tassazione straordinaria, arbitraria e irregolare, la cui entità e frequenza dipendevano dalle necessità finanziarie dovute a guerre, opere pubbliche, spese personali e simili.
(6.10) Sotto il profilo etimologico, si potrebbe ipotizzare l’origine comune dei termini royda e "roggia". Entrambi sembrano derivare da una divergenza evolutiva del tardo latino arrugia, forse di origine preromana (rugia). Inizialmente, arrugia avrebbe identificato un cunicolo, una galleria o un canale artificiale minore, ma col tempo il significato si estese a quello di canale a cielo aperto, soprattutto nell'Italia settentrionale. La royda (o roida) rappresenterebbe quindi un'antica forma dialettale del Piemonte, usata sia per il canale che per l'obbligo a lavorarvi. "Roggia" è invece è la forma consolidata nell'italiano moderno. Va osservato che se è documentato il passaggio da rugia ad arrugia a "roggia" non altrettanto lo è con certezza la transizione verso forme come royda.
(6.11) Ad esempio, il 30 agosto 1390 venivano pagati sei soldi per ogni carro di rami condotto alla Stura, e tre soldi per ogni carico di pietre prelevate dal bosco di Collegno. Il 17 marzo 1376 il Comune remunerava con tre soldi ogni carrata di vimini, terra o pietre condotta alla via della Porta Secusina, nei pressi del canale.
7. Funzioni e utenze
Le funzioni
Nel corso del Trecento, la bealera comunale svolgeva principalmente funzioni civiche e irrigue. Essa serviva le campagne a sud-ovest di Torino — più prossime all'abitato e più coltivate rispetto a quelle dell’Oltredora e dell’Oltrestura — con l’arativo e il prato in posizione predominante e l’incolto confinato nelle aree marginali. (7.1) Le sue acque irrigavano anche i vuoti urbani entro le mura destinati a orti e verde produttivo, testimoniando al tempo stesso sia la crisi demografica sia il confine sfumato tra campagna e città e la diffusione dell’autoconsumo pure tra i ceti urbani. Contribuivano inoltre a ripulire strade e mercati, mantenendo condizioni igieniche accettabili e riducendo il rischio di epidemie. I numerosi articoli degli Statuti dedicati confermano come la sanità pubblica fosse una preoccupazione primaria dell'amministrazione comunale. (7.2)
L'affermarsi dell’attività manifatturiera e la moltiplicazione delle ruote idrauliche lungo il canale avvennero soprattutto nel XV secolo, sebbene le prime istanze risalgano già alla fine del XIV. La prima fu probabilmente avanzata il 17 aprile 1379 da Stefano Borgesio per unum batenderium rusche et unum molendinum ad molendum gallam — ovvero un battitore e un mulino per la macinazione della corteccia di rovere (rusca) e delle galle (il frutto della quercia contenente la ghianda) — da costruire tra la porta Colleasca e la chiusa (exzancoram) di Ardizzone Arpino. Da questi materiali si estraeva il tannino, sostanza indispensabile per la concia di cuoio e pelli. Una seconda richiesta, per un batenderium rusche e un molendinum galle da collocare in un punto da definire della bealera, fu avanzata da Zaberto di Lucerna il 3 marzo 1392. (7.3)
L'uso a fini manifatturieri delle acque è confermato dal divieto imposto a conciatori, tintori e pellai di gettare gli scarti di lavorazione nelle vie pubbliche o nel canale che attraversava la città, così come dall'ordinanza emanata il 10 marzo 1375, che proibiva il lavaggio delle pelli nella bealeria comunis presso San Solutore, sotto pena di una multa di dieci soldi. Saranno proprio i "martinetti" quattrocenteschi, macchine a movimento alternato verticale, a ispirare il nuovo nome della bealera. (7.4)
Le utenze
Gli affittuari dell'acqua erano numerosi, a testimonianza della funzione realmente pubblica della bealera, e appartenevano prevalentemente a famiglie aristocratiche e a esponenti dei populares più abbienti che costituivano l'élite cittadina. Gli atti di concessione variavano da periodi di cinque o sei anni fino a durate più lunghe, come ventinove anni o l'enfiteusi perpetua, e venivano spesso rinnovati alla scadenza.
Gli allacciamenti diretti erano circa una dozzina e le autorizzazioni accordate erano pertanto relativamente rare, come attestano le verbalizzazioni degli Ordinati. Tuttavia, i proprietari delle prese dirette cedevano a loro volta l’acqua ai possessori dei terreni più distanti, ampliando sensibilmente sia la superficie irrigata complessiva sia il numero gli utenti. La distribuzione era regolata da un calendario, con orari e giorni della settimana prestabiliti, che variavano secondo le esigenze le dimensioni dei fondi. Strutture e diritti d'acqua entravano a far parte delle proprietà; le ore d'irrigazione, in particolare, erano oggetto di mercato e alimentavano vivaci compravendite, con prezzi che crescevano parallelamente alla diffusione dei prati. (7.5)
Le fonti più ricche di informazioni sulle utenze sono i censimenti delle prese irrigue della bealera, redatti sia per ripartire i costi delle riparazioni, sia per contrastare i prelievi non autorizzati. Una delle testimonianze più interessanti è quella del 3 novembre 1488, i Testimoniali di visita, compilati con lo scopo di «inibire in avvenire di impedire, usurpare, o prender ne di giorno, né di notte l’acqua discorrente per la bealera Pelerina, osij Coleasca et fossato longo, suoi bochetti senza licenza, et autorità delli Sigg. Sindaci della Città, sotto pena di 20 marche d’argento per ogni volta applicabili, la mettà al fisco Ducale, e l’altra mettà alla Città», dei quali si riporta un estratto. (7.6)
Dei tredici bochetti:
-
«Il primo di detta bealera si ritrova sulle fini di Torino, e la regione dove si dice il Cono (Conum), il qual bochetto si prende, e va verso la Grangia dei fratelli de Madi e suoi consorti;
-
Il secondo fu ritrovato verso li poderi del signor Ribaldino e fratelli de Beccutis;
-
Il terzo verso li poderi e prati dei nobili Giovanni Michele e Stefano fratelli de Beccutis e Odone Vaudagna e altri consorti;
-
Il quarto bochetto si ritrovò verso li prati e possessioni di Giovannetto e Guglielmino di Vaudagna, eredi del fu Bertino Vaudagna.;
-
Il quinto bochetto restava situato verso le possessioni e poderi di Giovanni Pianotto, Giovannetto Vaudagna, Michele Dainerj, Bartolomeo de Madis, Bernardino Massotto e altri consorti;
-
Il sesto bochetto resta verso li beni d’Antonino Tosco e altri suoi consorti;
-
Il settimo bochetto va verso li beni del Nobile Goletto Gastaudi, et Turinetto Muratore, et altri suoi consorti;
-
L’ottavo bochetto resta verso li beni dello spettabile signor Michele Buri, et il nobile Franceschino de Crovesio e altri suoi consorti;
-
Il nono bochetto va verso li beni del nobile Michele Maletto, et altri suoi consorti;
-
Il decimo bochetto fu ritrovato a esser verso le possessioni della 'Ecclesia Dompni' (Capitolo Metropolitano) le quali sono tenute dal venerabile 'dominus' Giovanni Galiardi Canonico di Torino, et ha indi discorso per molti altri prati verso la Chiesa e prati di Sant’Agostino (7.7);
-
L’undecimo bochetto resta verso li possessioni di Chiaffredo, e fratelli de Calcagno, Giovannetto Calcagno, Matteo di Rivalta, et Bartolomeo Marescali, et altri consorti;
-
Il duodecimo bochetto resta situato verso li beni delli nobili Guglielmo et Bartolomeo Borghesi, et altri consorti;
-
Il decimo terzo bochetto si ritrovò doversi prender sovra il canale di porta Secusina, et entra nella Bealera del fossato longo, et ha due discorsi, cioè verso Santa Margherita, et sino al Po. L’altro discorso verso li Monterussii, e San Salvario, passando appresso la cassina de fratelli Daherij. (lat. de Auris).
Il documento individua circa sessanta «legittimi possidenti dell’acqua della bealera» (7.8) Va però osservato che simili elenchi non restituiscono la realtà, assai più dinamica, dei passaggi di proprietà dei titoli di derivazione e dei fondi agricoli. Purtroppo, i riferimenti territoriali, pur interessanti, non sono sufficienti per ricostruire i tracciati; la localizzazione stessa delle prese può risultare problematica, sia per la genericità del dato, sia per una toponomastica in gran parte ignota o dimenticata.
note 7 __________________________________________
(7.1) I terreni oltre la Stura erano costituiti per oltre il 40% da incolti, suddivisi fra boschi, gerbidi, gorreti e pietraie. Grande spazio spettava al pascolo, mentre soltanto il 4 per cento era arativo. La situazione era migliore tra la Stura e la Dora, dove il 72% della superficie era occupata da terreni arativi, a fronte a un 15% di pascoli, e il boschivo non superava il 5 per cento dell'incolto. Cfr. M.T. Bonardi, A. Settia, La città e il suo territorio, in Storia di Torino Einaudi, Vol. II, cit, pag. 88.
(7.2) Per le norme igieniche e sanitarie della Torino medioevale, cfr. idem, p. 8 e segg.
(7.3) Nel caso di Stefano Borgesio, il Consiglio si riservò la decisione finale, mentre per Zaberto la risposta venne demandata ai ragionieri del comune, con deliberazione a maggioranza dei 2/3. Le successive verbalizzazioni non riportano notizie sull’esito delle domande e, data la loro somiglianza, non si può escludere che quella di Zaberto, riguardasse lo stesso impianto del Borgesio. Sempre a proposito degli opifici idraulici trecenteschi, va menzionata la domanda di Giserio (Dixerio?) de Cabureto del 4 aprile 1387, per costruire una pesta da rusca e una sega idraulica (rexiam et batanderium de ruscha) sul Sangone, oppure su una bealera derivata dal torrente che attraversava il Pratum de Piacia Camererio, situato nel territorio di Torino. L'ispezione del 29 dicembre alla ficha edificata da Gisserio parrebbe confermare l'esito positivo della richiesta.
(7.4) Per una dettagliata disamina della questione, cfr. M.T. Bonardi, Canali e macchine idrauliche nel paesaggio suburbano, in "Acque, ruote e mulini a Torino, vol. 1", a cura di Giuseppe Bracco, Torino, Archivio storico della Citta di Torino, 1988. pag. 105 e segg.
(7.5) Per il trend dei fitti delle ore d'acqua cfr. C. Rotelli, Una campagna medioevale. Storia agraria del Piemonte tra il 1250 e il 1450, Einaudi, 1973, Pag. 115.
(7.6) Cfr. ASCT, CS 1924 per il testo in latino e CS 1845 per quello in volgare.
(7.7) Dopo l'allontanamento degli Umiliati, avvenuto nel 1427, i loro beni furono divisi tra gli Eremitani di Sant'Agostino e le monache di S. Chiara. Cfr. fig. 3.3
(7.8) Per i loro nomi cfr. ASCT, CS 1924. Altri elenchi di proprietari di concessioni d'acqua si ricavano dai prestiti forzosi imposti dal Consiglio per la riparazione della bealera o della ficca. A tal proposito si considerino, tra le altre, le verbalizzazioni del 31 marzo 1387 e del 6 gennaio 1392, nonchè la nota (c) della scheda del par. 8. In questi elenchi i partecipanti differiscono spesso sia per numero che per identità.
8. I Tracciati
Il tracciato "ufficiale" della bealera Colleasca può essere considerato quello contenuto negli Statuti del 1360, secondo i quali «fluisce dalla ficca sulla grande Dora fino al Po, passando sia fuori dalla città e i sobborghi, sia entrando nell’abitato con il canale della porta Segusina». (8.1)
La ficca Pellerina e gli scaricatori
La realizzazione della bealera non ha richiesto opere o sbancamenti di rilievo, ma soltanto lo scavo di un alveo con argini capaci di contenere le acque più abbondanti, livellato per superare la differenza di quota tra il fiume e la città. Ragioni altimetriche e di controllo strategico-politico collocano la ficca Pellerina nell’ultimo fines (confine) torinese, almeno un paio di miglia a ovest della città. Tale posizione è confermata dalla vicinanza all’imbocco del bocchetto della famiglia de Madis, il primo della bealera. (8.2) Materiali e caratteristiche costruttive della traversa sono descritti nella scheda che segue.
Materiali e tecniche costruttive della ficha Pellerina
Il contratto stipulato il 18 febbraio 1376 con Michele de Aglo per la ristrutturazione della ficca Pellerina offre interessanti informazioni comuni a tutti gli sbarramenti fluviali storici. Costituiti da una o più file parallele di robusti pali di rovere, tali manufatti rimasero pressoché invariati per caratteristiche, materiali e modalità costruttive, fino all'avvento del cemento armato.
Fin dal 5 maggio dell’anno precedente, la responsabilità dell'opera era stata affidata al massaro comunale, incaricato anche di riscuotere i fitti arretrati del priore di Sant'Andrea e di altri per coprire la spesa. Qualora il denaro non fosse stato sufficiente, i clavari era stati autorizzati a consegnargli fino a 20 fiorini di 32 soldi ciascuno. (a)
Solo il 10 febbraio 1376, tuttavia, sono nominati i 'boni viri' — Bonifacio Beccuti, Giovanni Ponzio, Nicolò Ainardi e Martino Tintore — investiti, insieme al massaro, dei pieni poteri per riparare e aumentare l'altezza della traversa. (b) Il 15 febbraio vengono assegnati i compiti: Bonifacio Beccuti, Nicolò Ainardi, Giovanni Ponzio e Ludovico de Cavagliata dovranno «contrattare e stipulare patti e convenzioni con Martino Tintore o altro mastro» per l'esecuzione dei lavori, affidati alla supervisione di Giovanni Ponzio. Perino de Gorzano, Ardizzone Alpino, Stefano de Coleto e Ricardino de Brossulo verificheranno la conformità ai patti, mentre i ragionieri del comune stabiliranno come reperire i fondi.
L'appalto non va a Martino Tintore, ma al mastro Michele de Aglo. Il contratto del 18 febbraio 1376, siglato con il massaro del comune, Nicolò Ainardi, prevede che: (c)
-
Michele de Aglo dovrà fornire e mettere in opera trenta pali di quercia, ciascuno lungo dieci piedi (circa 5 metri) e «così grosso che una 'paustrusa' di castagno pesi quanto tre di essi». I pali avranno una robusta punta di ferro, del peso di almeno quattro libbre, e saranno «conficcati» nel fondo del fiume per una profondità di cinque piedi (circa 2,50 m) mediante un 'becho'; (d)
-
Il suddetto Michele dovrà legare e intrecciare saldamente la ramaglia ai pali per rafforzarli, zavorrandola e imbrigliandola alla base con grosse pietre. Dovrà inoltre consolidare un 'sapello' — una palizzata o comunque un elemento che sembra regolare e/o favorire l’ingresso delle acque — rivolto verso l’imbocco della bealera, da rinforzare anch’esso con intrecci di ramaglia e pietre;
-
Per gli interventi pattuiti, il suddetto Nicolò promette di pagare a Michele trentadue fiorini di trentadue soldi viennesi ciascuno, 10 dei quali al termine dei lavori, «salvo approvazione e soddisfazione dei 'saggi'». Il Comune concederà l’uso del 'castrum' e del 'bechum', entrambi da riconsegnare al massaro dopo l'uso. Michele dovrà mettere in opera inoltre quattro 'cavalletos', per i quali riceverà un ulteriore fiorino, oltre ai 32 pattuiti; (e)
I danni alle opere di presa si rivelano però più gravi del previsto, e le condizioni contrattuali vengono superate dalle necessità del cantiere. Il 21 febbraio, su delega del Consiglio, i ragionieri comunali ordinano al massaro di anticipare i pagamenti, consegnando trentatré fiorini a Michele de Aglo e due a Giovanni Ponzio. L'imboccatura della bealera è bloccata dal fango e, per liberarla, viene comandata una royda rivolta ai 39 utenti della 'bealera comunis' — riportati in nota — i quali, sotto pena di due soldi di ammenda, dovranno fornire da uno a tre lavoranti ciascuno, per un totale di ben 59 uomini. (e) (f) Le difficoltà incontrate alla Pellerina richiederanno ripetute ridefinizioni degli accordi, approvate nelle sedute del 23 agosto e 23 settembre 1377, 28 dicembre 1378 e 22 luglio 1379. Al termine, a Michele de Aglo sarà riconosciuto un compenso straordinario di 100 soldi viennesi, liquidato l'11 settembre 1379.
note __________________________________________
(a) (Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. VI, p. 358.
(b) (Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. VII, p. 8.
(c) (Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. VII, p. 11.
(d) La paustrusa di castagno sembra essere una misura di peso di cui si è persa notizia. Il becho pare invece riferibile a un ariete o a una mazza battipalo, (forse dal francese bélier) usato per conficcare i pali nel letto del fiume. Dal latino figere — «conficcare, piantare saldamente» — deriva la parola ficca, divenuta sinonimo di traversa fluviale.
(e) Il castrum pare un'impalcatura o un elemento di sostegno/supporto utilizzato per l’innalzamento della ficca. Il termine potrebbe derivare dal francese antico, chastel, che designava una piattaforma soprelevata o, per l’appunto, un'impalcatura. I cavalletos parrebbero strutture in legno — forse piccoli pali o supporti — utilizzati per erigere o consolidare la palizzata.
(f) Sono coinvolti nella royda: Antonio de Nicholosio, Domenico Calcagno, Antonio Calcagno, Nicolò Ainardi, Francesco Borgesio, Rana Beccario, Giovanni di Revigliasco, Bartolomeo Borgesio, Oberto de Gorzano, Franceschino Gastaldo, Paganino Borgesio, Martino Borgexio (e fratello), Bonifacio Beccuti, Ardizzone Alpino, Nicola Beccuti, Andreina de Montalto (Domina), Corrado de Montalto, Stefano Borgesio, Giacomo Borgesio, Florio della Rovere, Domenico de Gorzano e fratello, Luchino Baracco, Antonietto Borgesio, Nicolino Malcavalero, Matteo de Pavarolo, Matteo Mozio, Tommaso Borgesio, Ugonetto Borgesio (Dominus), Zabo Alpino, Brunetto della Rovere, Ludovico de Cavagliata, Guglielmo Mazucco, Giovanni Perracchio, Pietro della Rovere, Giovanni Rayneri, i Frateti Umiliati, il Priore di Sant'Andrea, gli Eredi di Bartolomeo Papa, l’Abate di San Solutore Minore, i Ponterii del Ponte di Po, gli Eredi di Nicolino Maschero.
Non è noto se fin dalle origini la traversa disponesse di uno scaricatore dedicato ad alleggerire la spinta dell’acqua e regolare il flusso immesso nella bealera, o se tale elemento sia stato aggiunto in seguito. La costruzione di «un fossato buono nel fondo e nelle sponde, attraverso il quale l’acqua del canale della Pellerina scorra fino al fiume Dora» fu approvata dal Consiglio nella primavera del 1373, dopo l’inondazione che aveva gravemente danneggiato la presa e la bealera, e distrutto il ponte di Porta Palazzo.
Lo scaricatore fu realizzato da Antonio Calcagno su un proprio terreno, con l'impegno, esteso ai propri eredi, di prenderne cura per i dieci anni successivi, ricevendo in cambio sedici lire viennesi. (Ordinati, 25 aprile 1374 e 8 aprile 1375). Tuttavia, esso non poteva coincidere con lo scaricatore della traversa, poiché le proprietà del Calcagno erano irrigate dall’undicesimo bocchetto e quindi troppo distanti da essa — almeno secondo i già citati Testimoniali del 1488, e a condizione che non ne possedesse altri.
L'ayvaverssum bealerie Pelerine (8.3) — così era indicato nei verbali — si mostrò subito vulnerabile, tanto che già nell’aprile dell’anno successivo richiese le prime riparazioni. Altri interventi si resero necessari in seguito, motivo per cui fu probabilmente aggiunto un secondo scaricatore, già previsto in origine. Nelle sedute consiliari del 28 maggio e del 1° giugno 1373, infatti, venne deliberata la costruzione di due nuovi canali pro tutione bealerie Colleasche, delegando ai sapientes l'acquisto dei terreni (Ordinati, 11 settembre 1373); ma per probabili ragioni di costo ne fu realizzato inizialmente solo uno.
L'efficienza degli scaricatori — purtroppo sempre citati senza ulteriori ragguagli — fu una preoccupazione ricorrente della Città, confermando l'importanza attribuita loro per il buon funzionamento del sistema. Del secondo condotto si hanno poche notizie e la sua posizione non è nota. Tuttavia, i due fiorini piccoli riconosciuti a Giovanni Calcagno il 19 gennaio 1385 per l’ennesima sistemazione della bealera e degli ayvaversos sembrano suggerire che il condotto fosse stato poi realizzato. L’uso del plurale è significativo e non casuale, essendo ripetuto nel verbale del 25 gennaio. È interessante notare che, in tale occasione, il Calcagno arrivò a minacciare di "rompere" la traversa per salvare i suoi prati: un gesto di inusuale violenza, forse dettato dall'esasperazione per i continui straripamenti, paventato e categoricamente proibito dal Consiglio.
Dalla Pellerina alla città
Sul tracciato della bealera che dalla Pellerina si snodava attraverso il territorio della Colleasca le informazioni non sono molte. I principali riferimenti riguardano il partitore del Fossato lungo, il borgo di San Donato e la sua porta, e il canale della Porta Segusina.
L'esatta posizione del borgo non è nota, tuttavia, poiché rientrava nel perimetro dei fossati cittadini, non poteva essere troppo distante dalla fortificazione. (v. scheda). La sua unica porta sembra delimitare la bealera Colleasca, ma al proposito le fonti sono contraddittorie. (8.4) Le concessioni di Giorgio Borgesio del 3 aprile 1325 e del 5 luglio 1332, così come il censimento delle prese del 1° febbraio 1392, suggeriscono che la bealera terminasse alle soglie del borgo; ciò è confermato da espressioni come «l’uso dell’acqua […] dall'imboccatura alla porta Colleasca» e «dalla presa fino alla porta del Borgo», nonché dalla verbalizzazione del 5 settembre 1389 (dicta bealeria a porta burgi usque ad Pelerinam). Un documento di rilievo, però — la nomina del 10 novembre 1383 di Martino Crosetto e fratelli quali massari della bealera — definisce le competenze «sull’acqua che scorre verso la città di Torino, cioè a partire dall’inizio di questa bealera, o dalla sua ficha, fino al cunicolo o bocchetto del muro della città di Torino, sul canale della Porta Segusina», lasciando quindi intendere che essa raggiungesse le cortine cittadine. La discrepanza è evidente, perché colloca la fine della bealera Colleasca e l’inizio del canale della Porta Segusina a distanze diverse dalla città, influenzando anche il nome assunto dalla bealera all’interno del borgo e il luogo di derivazione del fossato lungo. L’esatta definizione di queste canalizzazioni non sembra una preoccupazione soverchia per l’amministrazione comunale, forse perché rientravano tutte sotto la sua giurisdizione.
Qualunque fosse il nome attribuitole, l'acqua proveniente dalla Pellerina attraversava il suburbio parallela alla strada di Collegno, come conferma la deliberazione del 1° dicembre 1374, relativa allo scavo di una certam bealeriam prope viam Coleasche a porta Coleasche usque ad canalem comunis per proteggere il transito di persone e carri da allagamenti e interruzioni. La soluzione non fu però risolutiva, se già il 23 maggio 1378 si dovette ordinare una royda ai proprietari dei terreni attraversati possessori di carri e buoi di trasportare tre carichi di pietre per ogni coppia di animali «dal canale della porta Segusina fino alla porta di Colleasca» nei luoghi indicati dai massari. La mobilitazione coinvolse anche gli altri proprietari, a cui fu affidata la pesatura dei carri.
Il canale della Porta Segusina
Il canale della Porta Segusina, ovunque avesse inizio, introduceva l'acqua nell'abitato. Il fossato ai piedi delle mura era scavalcato da un ponte-canale, parallelo al passaggio riservato a uomini, animali e carri (la viam porte Secuxine prope canalem, Ordinati del 17 marzo 1376), mentre le mura erano oltrepassate attraverso un cunicolo che prendeva il nome dalla porta stessa. Queste strutture artificiali d'alveo giustificano forse l'uso del termine "canale” per distinguerlo da una più semplice "bealera" scavata direttamente nel terreno. Come tutti i ponti in legno, anche questi erano soggetti a guasti e cedimenti, e nelle verbalizzazioni consiliari è spesso annotato che «pontem portae Secusinae noviter derutum est»
Il pontetum Choleasche
Le intersezioni dei corsi d'acqua artificiali con le strade erano senza dubbio numerose; tuttavia, molti attraversamenti avvenivano a raso, senza la necessità di ponti. Sono quindi degne di nota le menzioni fatte dagli Ordinati di un modesto ponte associato al borgo di San Donato, definito di volta in volta: ponteto porte Colleasche (Ordinati 25 marzo 1373), pontetum porte Burgi (Ordinati 1 aprile 1389), pontetum aqueversi (Ordinati 7 giugno 1389), pontetum Choleasche, iusta portam Burgi (Ordinati,19 maggio 1392) o soltanto pontem Coleasche (Ordinati, 2 aprile 1377 e 23 maggio 1378). Esso sembra corrispondere al pontem Sancti Bernardi, in riferimento alla chiesa e al convento di San Bernardo, e all’angolo nord-occidentale della fortificazione, confermando così il legame con il borgo. (fig. 8.2) (8.5) La frequenza delle citazioni segnala il ponte come un riferimento territoriale ben riconoscibile; i motivi della sua particolare ricorrenza restano indefiniti, ma si può supporre che collegasse le due parti dell'agglomerato divise dalla bealera. Il «pontetum apud nucem de Vaudagna in Valedoc», da ripristinare dagli abitanti che se ne servivano (Ordinati, 28 ottobre 1378), passava plausibilmente su un corso d'acqua artificiale, ma non è noto dove crescessero i «noci di Vaudagna» e di esso non si hanno altre notizie.
Il Fossato lungo
Il Fossato lungo, secondo i Testimoniali del 1488, «si ritrovava doversi prender sovra il canale di Porta Susina, et entra nella Bealera del fossato longo» — in altro documento: repertu fuit essa captus super canalj porte Secuxine, et intrans Bealeriam fossati longi — si presta a una doppia interpretazione. L’espressione super canalj può infatti essere intesa come “sul canale”, e dunque indicare una derivazione diretta da quello della Porta Segusina, ma potrebbe anche rimandare a una presa “precedente”, ossia a monte di esso. La prima ipotesi collocherebbe l’inizio della bealera a ridosso del fossato difensivo e delle mura, mentre la seconda almeno 6-700 m più a ovest. È singolare osservare che la presa è la tredicesima e ultima e sembra segnare quindi la fine della «bealera Pelerina, osij Coleasca et fossato longo». Dopo non se registrano altre (v. fig. 8.1), ma che varie fonti attestano che il Fossato lungo serviva numerose utenze.
La costruzione della Cittadella cinquecentesca di Emanuele Filiberto ha alterato l’assetto idraulico medievale e potrebbe aver determinato la modifica del tracciato del Fossato lungo, obbligandolo ad aggirare la nuova fortezza. Questo potrebbe spiegare lo scarto fra le due ipotesi, ma lo stato delle fonti non consente lascia aperta la questione.

Fig. 8.1 Il particolare col-loca l'inizio dei due rami del Fossato lungo a una certa distanza dalla Porta Segusina, oggi alle spalle di largo Cibrario. Occorre però cautela, poiché l'uso di una mappa successiva di tre secoli pone limiti evi-denti: alla bealera Collea-sca, ad esempio, sono at-tribuiti solo 10 bocchetti, anziché i 13 del 1488, e il Fossato lungo non ha ori-gine dall’ultimo, ma dal sesto. Ciò suggerisce una configurazione delle prese diversa, forse dovuta alla edificazione della Cittadel-la.
ASCT, CS 1977 (particolare)
Dopo un tratto comune, le acque del Fossato lungo si dividevano in due parti (fig. 8.1). La sola indicazione sul luogo della ripartizione proviene dalla mappatura seicentesca, che lo pone non lontano dalla punta del bastione più meridionale della Cittadella (oggi all'ncirca all'incontro dei corsi G. Ferraris e Re Umberto), con le cautele già espresse riguardo a questa fonte.
Il ramo sinistro, o bealeria Sancte Margherite
Il ramo sinistro scorreva «fuori le mura» meridionali «verso Santa Margherita, in direzione del Po». La chiesa di Santa Margherita del Tempio, talvolta considerata un unico complesso con la vicina chiesa di San Severo, risaliva al XII-XIII secolo, apparteneva all’Ordine dei Templari ed era situata nell'angolo sud-orientale della fortificazione, sulla strada foranea che collegava le porte Fibellona e Marmorea. (fig. 8.2) (8.6)
La descrizione e il riferimento alla chiesa di Santa Margherita trovano conferma nelle prime testimonianze del sistema idraulico torinese: sia nella concessione del 1317 «dello acquedotto e uso dell'acqua discor-rente pel fossato lungo fuori le mura della città verso Santa Margherita», (8.7) sia in un atto del 1321, secondo cui «la bealera del fossato lungo, che scorre dall’angolo o fossato esistente di fronte alla chiesa di Santa Margherita vicino alle muraglie della città di Torino verso il fiume Po, proveniente dalla bealera Colleasca quale si estrae dalla Dora». (8.8)

Fig. 8.2 La ricostruzione di A. Zolla riporta i quattro grandi complessi religiosi agli angoli della cinta muraria. In basso a destra, in quello sud-orientale, si distinguono le chiese di San Severo e Santa Margherita, e la strada che corre esternamente alle mura, tra la Porta Fibellona e la Porta Marmorea.
Fonte: A. Zolla, Torino medievale....tra XI e XV secolo,
in: "Il tesoro delle città", Steinhäuser Verlag Editore, 2018.
Questo corso era probabilmente noto come Bealeria Sancte Margarite. L'idronimo compare nei Consegnamenti catastali del 1369, tra le coerenze delle diciannove giornate di prato irriguo denunciate da Ardizzone Arpino (8.9), e negli Ordinati del 17 marzo 1376, in relazione agli allagamenti lungo la strada da porta Fibellona a Santa Margherita. A una sua diramazione apparteneva con ogni probabilità anche il «ponte sulla via del ponte del Po», che usciva da quella porta e che il 18 luglio 1390 necessitava di riparazioni.
Da tempi remoti, nella stagione irrigua, gli scoli del Fossato lungo erano diretti verso i prati di Vanchiglia. Tale pratica è attestata dall’ordine del 23 aprile 1378, che disponeva l'installazione di una chiusa (exclausoiram) per deviare l’acqua verso quella regione, «così come era consuetudine che essa fosse e venisse fatta in altri tempi». Ragioni morfologiche e altimetriche suggeriscono che fosse questa parte del canale a svolgere tale compito, ipotesi sostenuta dalla deliberazione del 19 febbraio 1385, che imponeva di riparare le «exchansoyras esistenti nel Fossato lungo, da cui l'acqua è deviata verso Vanchiglia».
Il ramo destro, o bealeria Valentini
Il ramo destro del Fossato lungo si allontanava dalla città volgendo a sud-est, verso il convento di San Salvario e il territorio fin da allora noto come Valentinum. (8.10) Per questo motivo era chiamato anche bealera Valentini, sebbene il tracciato corrispondesse solo in parte alla bealera omonima attestata successivamente. Nel suo «discorso» lambiva i monterussi, (o monterucij), modeste alture fra la Porta Marmorea e San Salvario — sulla cui origine, naturale o artificiale, le interpretazioni sono discordi — e la Cassina Daherij, menzionata altre volte come Grangia de Auris. (8.11)
La pexina ranea
Un elemento associato al Fossato lungo era la cosiddetta pexina, o pexina ranea. Il termine – corruzione del latino piscina, già di per sé evocativo – indicava una polla naturale, o uno stagno, collegati a una sorgente oppure alla bealera. Nell'economia rurale, gli stagni rivestivano un ruolo importante: lo sfruttamento ittico e l'allevamento di animali acquatici fornivano cibo nei periodi in cui era proibito il consumo di carne, oltre a costituire una buona riserva d’acqua. La prima menzione di un locum taurini denominato pixina ranea compare nell'atto di vendita di una pezza di terra, datato 14 aprile 1153; (8.12) essa è seguita da menzione analoga del 1219, contenuta nella donazione di un campo di terra arabile fatta dalla badessa del monastero di San Pietro all'abate di San Solutore (8.13). Nel 1316, viene concessa ai fratelli Costanzo e Margherita Marescalco l'acqua di una canaletta proveniente dal Fossato lungo per irrigare le terre possedute iusta pessina (8.14). Il 20 agosto 1382, il Consiglio accertava che l'acqua della bealerie Valentini, rotti gli argini prope Pexinam, si riversava in essa, con grave pregiudizio per le proprietà circostanti. Nella deliberazione del 2 aprile dell'anno successivo, oltre al ripristino degli argini del Fossato lungo, si ordinava ai proprietari di modificare le scansoyre per evitare il ripetersi di simili incidenti.
La sua ubicazione rimane incerta, e neppure i nomi delle proprietà più vicine offrono indizi decisivi per determinarla. Sebbene la prossimità alla vie Valentini e alla bealerie Valentini possa suggerire una collocazione lungo il ramo destro della bealera, il campo di terra arabile già citato — sito in territorio Taurini ad Piscinam Raneam, confinante con la chiesa di Santa Margherita de Templo — induce piuttosto ipotizzare una posizione sul ramo sinistro. (8.15)
Altre bealere dalla porta Segusina e la bealera di Vanchiglia
Il sistema idraulico trecentesco sembra completarsi con altre due bealere, entrambe con origine dalla Porta Segusina, e dalla bealera di Vanchiglia, a queste strettamente connessa. La prima scorreva nel fossato settentrionale, uscendo in direzione di Vanchiglia; la seconda convogliava le acque residue della bealera Colleasca verso i mulini di Porta Palazzo. (vedi fig. nella scheda Un'inferenza cartografica)
Lungo il fossato della fortificazione
La canalizzazione è attestata da più fonti: innanzitutto dall’atto del 30 giugno 1344, con cui il principe Giacomo di Savoia concede a Nicoletto Porcello «tutta l’acqua che scorre, o scorrerà in futuro, attraverso il fossato della città, dal canale presso la porta Segusina, per il quale l’acqua scorre verso la città, fino alla torre lunga e da lì fino a Vanchiglia» (8.16); inoltre, dalle Patenti del 27 novembre 1353, sempre emanate dal principe Giacomo; infine, da una memoria seicentesca del marchese di San Ramberto, figlio naturale del duca Emanuele Filiberto, all’epoca, concessionario di quest’acqua.
Nelle Patenti del 1353 si fa menzione delle acque che fuoriuscivano dalle mura attraverso i cunicoli delle porte Pusterla, San Michele e Palazzo, le quali dovevano necessariamente confluire nel fossato settentrionale. La memoria del marchese di San Ramberto, probabilmente databile alla prima metà del XVII secolo, descrive il sistema idraulico in cui si colloca questo corso d'acqua nei seguenti termini:
«Nel canale di legno, che a porta Susina attraversando i bastioni porta la bealera in Torino vi esisteva dappiù di due secoli come di esiste tuttora uno scaricatore per riversare nel fosso l’acqua soverchia, la quale per un piccolo fosso discorrendo come oggi appiè delle mura veniva nell’accennato suo corso inquinata da quei colaticci, che in detto tratto uscivano dal recinto della città per gli antichi tre bucchi, ossia scaricatori detti della Consolata, San Michele e Porta Palazzo». (8.17)
Il documento conferma la funzione essenziale svolta nel sistema di regolazione idraulica urbano. L'acqua che entrava in città doveva essere controllata, così da disperderne l’eccesso, fino a interromperne il flusso quando necessario, ad esempio nei casi in cui i condotti urbani venissero temporaneamente prosciugati; lo scarico avveniva attraverso le paratoie sistemate nel ponte-canale della Porta Segusina, come descritto anche nella fonte, con il deflusso che si riversava direttamente nel fossato.
Molti indizi indicano con buona certezza che i fossati venissero colmati solo in particolari circostanze — in primo luogo in caso di minaccia militare — mentre per il resto del tempo restavano asciutti (8.18). Per ragioni altimetriche, lo svuotamento avveniva verso est, dove il terreno era più basso: condurre le acque in quella direzione, e strutturare così l’irrigazione dell’area di Vanchiglia, rappresentava una soluzione logica e funzionale.
Verso i molini di Porta Palazzo
Questa canalizzazione non sembra invece trovare menzioni esplicite nelle fonti. Sebbene compaia nella cartografia seicentesca, non è possibile attribuirle un nome certo, e la stessa esistenza nei secoli precedenti, per quanto plausibile, rimane incerta e legata alla questione se il corpo d'acqua proveniente dalla Pellerina entrasse interamente in città, oppure se il canale della Porta Segusina costituisse una diramazione della bealera principale, le cui acque proseguivano verso altri luoghi.
Pur in assenza di prove dirette, il collegamento appare plausibile per una duplice ragion d’essere. Da un lato, avrebbe contribuito ad assolvere le funzioni di regolazione e di scarico del sistema idrico urbano già menzionate; dall’altro, avrebbe evitato l'inutile dispersione dell’acqua non impiegata per la città o per le irrigazioni, destinandola ai terreni prossimi all’abitato — certamente tra i più coltivati —, ai mulini e ai prati di Vanchiglia. Proprio a partire da tale funzione, si può ipotizzare che la canalizzazione potesse corrispondere a uno degli scaricatori aggiunti alla bealera Colleasca nel corso del Trecento, circostanza che spiegherebbe la mancata attribuzione di un nome specifico.
Essa sembrava seguire la strada di circonvallazione parallela alle mura e al fossato — forse la stessa «che dal canale di Pietro della Rovere va fino alla torre di Sant’Andrea» (Ordinati, 7 giugno 1389) —, per poi confluire nel canale dei mulini e nella bealera di Vanchiglia. È possibile che, se le due descrizioni si riferissero al medesimo corso d’acqua, questo coincidesse con la bealeria comunis (sic) «che va dal ponteto della porta di Colleasche fino a Venchilliam», menzionata negli Ordinati del 25 marzo 1373. In tal caso se ne confermerebbe non solo l’origine medievale, ma anche la plausibile identificazione con la bealera — forse quella detta “vecchia” — di Vanchiglia, ipotesi non in contrasto con quanto appena formulato.
Un ulteriore indizio a sostegno di tale collegamento proviene dalla richiesta — già menzionata — di Stefano Borgesio (1379) di installare alcune macchine idrauliche sulla bealera Colleasca. A prima vista, la commissione istituita dal Comune il 17 aprile 1379 per accertare se queste macchine potessero «arrecare danno al signore nostro il principe d’Acaia» sembrerebbe una semplice cortesia istituzionale, ma il significato di tali cautele cambierebbe se l'acqua della Colleasca avesse raggiunto gli "ingegni" ducali sulla bealera dei Molini.
La bealera di Vanchiglia
Fin dall'epoca medievale il nome di Vanchiglia indicava il territorio a nord-est della città, che dalla Porta Fibellona si estendeva verso il Po e la Dora. Secondo G. Casalis, esso compariva già nel 997 d.C. nei documenti dei canonici del Salvatore. Si trattava di un'area marginale, spopolata, malsana e povera, caratterizzata da terreni umidi e paludosi. Vi prevalevano i prati, favoriti dalla posizione geografica e altimetrica, oltreché dagli scarichi urbani — naturalmente ricchi di principi fertilizzanti derivati da scarti e deiezioni raccolte nelle strade cittadine — utilizzati a beneficio di un'area altrimenti difficile da coltivare.
La canalizzazione che assolveva tale compito, strettamente collegata alle due precedenti, era la "bealera di Vanchiglia". Nel tempo si configurò come un articolato sistema di raccolta delle acque reflue: probabilmente ad una prima bealera, detta "vecchia", che da tempi remoti raccoglieva le acque dei molini dopo l'uso, si aggiunse in seguito il condotto che apportava le acque provenienti dal fossato e dalla città. La cronologia di questa rete meriterebbe ulteriori approfondimenti. È noto, comunque, che nella seconda metà del XIV secolo alcuni membri dei Borgesio, un della Rovere e un Pertusio formarono un consorzio per reperire i capitali per lo scavo di un canale diretto in Vanchiglia. La circostanza è documentata sia dai diritti denunciati da Giorgio Pertusio (Pertuxio) del fu Michele nella dichiarazione catastale del 1363, sulla «bialera tanto fatta quanto da farsi per portare l'acqua dalla grande bialera dei mulini verso Vanchiglia», sia da quelli denunciati tre anni dopo da Brunetto della Rovere (Brunetus de Ruvore) su «tutta l’acqua che è condotta verso Vanchiglia mediante la bealera da lui stesso fatta con altri soci, recentemente costruita e alimentata presso la grande ficca dei mulini». (8.19)
Fig. 8.3 Il sistema idraulico medievale torinese sembra completarsi con tre altre canalizzazioni: quella che dalla Porta Segusina scen-deva verso Porta Palazzo (in turchese), quella che per-correva il fossato difensivo (in blu) e la bealera di Vanchiglia (in verde), di cui il disegno seicentesco mette in evidenza un ramo "vec-chio".
Fonte: ASCT, CS 1977 (particolare).

note 8 __________________________________________
(8.1) Bealerie Coleasche decurrentem a fica seu bichocha magne Durie ussque in Padum extra civitate et suburbia seu versus canalem porte Secuxine, (Capitolo CLIV degli Statuti della città di Torino del 6 giugno 1360. Cfr. D. Bizzarri, Gli Statuti del comune di Torino del 1360, cit.
(8.2) Cfr. Figura 2.3 e i Testimoniali di visita del 1488, cit.
(8.3) Gli scaricatori sono indicati con parecchie varianti linguistiche, come evaverssii, evaverssum ed altre ancora (forse perché si trattava di un neologismo creato per un nuovo elemento idraulico?)
(8.4) La toponomastica, negli Ordinati, non è sempre coerente. Ne costituisce esempio, il sommario della seduta consigliare del 1° febbraio 1392, dove szansoyras, cunicullos et bochetos bealerie Choleasche et foxati longi citati nell'ordine del giorno, nella verbalizzazione diventano omnes cunicullos et bochetos existentes in bealeria Choleasche videlicet ab intrata dicte bealerie usque ad portam Borgi. Una lettura puntuale implicherebbe una definizione contraddittoria della bealera, o il riferirsi a canalizzazioni differenti, quando è evidente invece che si tratta di una semplice imprecisione nella scrittura.
(8.5) Cfr. L. Cibrario, Gli Ospedali di Torino nel Secolo XIV, ristampa del 1963 negli "Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino e della Società Storica delle valli di Lanzo", p.17.
(8.6) F. Rondolino riunisce San Severo e Santa Margherita in un solo centro religioso, come pure G. Casalis, attribuendo entrambe ai Templari. Cfr. F. Rondolino, Storia di Torino antica (dalla origine alla caduta dell'Impero), Fratelli Bocca, Librai di S. M, Torino, 1930, p. 344 e G. Casalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale cit. Vol. 21, p. 489 , — Nel 1319, il complesso fu donato dalla badessa del monastero di San Pietro al monastero di San Solutore.
(8.7) Cfr. ASCT, CS 1868.
(8.8) Cfr. ASCT, CS 1881.
(8.9) Cfr. ASCT, Libri dei Consegnamenti, Porta Pusterla, 1369, carta 89r.
(8.10) Una vie que est aput Pexina qua itur ad Valentinum è menzionata nell'Ordinato del 4 febbraio 1328.
(8.11) Nella località detta “in Monteruchiis”, vicino al prato di San Severo, luogo fuori città, nei pressi di Porta Marmorea, si teneva a novembre la fiera di Ognissanti, una delle più importanti per la compravendita degli animali. (Cfr. R. Comba, L'economia, in Storia di Torino, Vol. II, cit, p.16.) — Dall’inizio del Duecento, formazioni simili sono descritte anche in altre parti del territorio metropolitano, (cfr. F. Rondolino, Storia di Torino antica, cit., p. 71).
(8.12) Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Pinerolo, Tip. Baravalle e Falconieri, 1912, p. 21, doc. 22 del 1153.)
(8.13) Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, cit. p. 40.
(8.14) Cfr. ASCT, CS 1886. L'atto costituisce probabilmente la più antica concessione d'acqua documentata nell'ambito torinese.
(8.15 Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, cit. p. 40.
(8.16) Cfr. ASCT, CS 1880).
(8.17) Cfr. ASCT, CS 2241).
(8.18) Si hanno notizie dell'adacquamento dei fossati extraurbani nel divieto di utilizzarne l’acqua per la lavorazione delle pelli e della canapa, ribadito più volte dal Consiglio (Storia di Torino Einaudi, vol II, p. 21), e nell'ordine del 13 luglio 1335, di far si che «l'acqua rimanga nei fossati», impartito dallo stesso, parallelamente alla istituzione della guardia armata alle porte Fibellona e Segusina. Tuttavia, la proibizione per le meretrici di esercitare nei fossati cittadini, sancita dagli Statuti del 1320 e il piano degli insorti Sili e Zucca di attraversare il fossato per raggiungere la Porta Palatina durante la rivolta del 1344 (ibid., p. 235) lasciano supporre che in altri periodi rimanessero asciutti.
(8.19) Cfr. ASCT, Collezione V - Porta Doranea, vv. 1031.

9. La Bealeria Molendinorum

10. L'acqua in città - (in corso di scrittura)
Le acque della Dora si distribuivano lungo le strade cittadine mediante un insieme di condotti, per i quali valgono, in sostanza, le medesime considerazioni formulate per le due bealere torinesi: la loro origine si perde in un passato così remoto da non poterne ricostruire con certezza le circostanze. È tuttavia plausibile che questi condotti, e la bealera Colleasca che li alimentava, siano stati realizzati nell'ambito di un unico intervento volto a soddisfare al tempo stesso le esigenze irrigue e l'approvvigionamento idrico dell’abitato; e che tale sistema, orientato da ovest verso est, ricalcasse in parte, e in superfice, i tracciati degli antichi condotti fognari sotterranei di epoca romana crollati e interrati da secoli. Va tuttavia osservato che, per entrambe le ipotesi, non vi sono prove documentarie o archeologiche dirette, e devono pertanto essere considerate come congetture coerenti ma non comprovate.
Le Patenti di Giacomo di Savoia, Principe d’Acaia, emanate il 27 novembre 1353, costituiscono una fonte di grande interesse per il livello di dettaglio e la ricchezza dei contenuti. Esse definiscono le misure volte a porre fine alle dispute sorte sull’uso delle acque cittadine, stabilendo la ripartizione dei flussi, le modalità esecutive e le responsabilità di gestione.
Patenti del 27 novembre 1353, mediante le quali Giacomo di Savoia ordina alla Città di Torino di distribuire nei modi specificati l’acqua della bealera Colleasca e del canale di Porta Susina.
Giacomo di Savoia, Principe d’Acaia, ai diletti nostri Vicario, Giudice e Capitano della Società della Città di Torino...
Siccome... abbiamo saputo che in tempi passati tra i nostri cittadini di Torino aventi il diritto nel deviar l’acqua della Dora scorrente e facente il percorso dalla bealera di Colleasca e dal Canale di Porta Segusina attraverso la nostra Città predetta molti abusi si sono verificati, [siamo intervenuti] affinché tanto l’oggetto di ogni abuso e questione tra i predetti nostri cittadini torinesi sia estirpato alla radice, quanto ciascuno di quegli stessi, circa la deviazione da farsi di detta acqua attraverso detta Città, sia contento del suo diritto, né ecceda o ampli in pregiudizio di altri, in ragione di consuetudini anticamente su ciò ottenute e osservate.
Tenuta in considerazione l’evidente e comune utilità di detta nostra città e dei suoi cittadini, i percorsi dell’acqua predetta... abbiamo deciso che siano divisi e regolati e che la stessa acqua sia ripartita come descritto, ossia che dal boccaglio di Porta Segusina e dal Cantone di San Dalmazzo fino alla Porta Fibellona, metà... discorra e scorra rettilinea lungo la roggia e la strada mediana e maestra di detta Città. E la quarta parte della stessa acqua... discorra e scorra attraverso le rogge e i cantoni di pietra delle Porte Nuova e Marmoria... lungo i quali e le quali era consueta scorrere. L’altra quarta parte di detta acqua scorra e discorra lungo i Cantoni e le rogge delle Porte Pusterla, di San Michele e del Palazzo, secondo come era solita scorrere.
In esecuzione di questa nostra divisione e ripartizione di detta acqua da noi fatta su consiglio di molti probi uomini di detta nostra Città di Torino, i quali il trattamento negoziale di detta acqua per niente tocca o sembra toccare, a voi e a ciascuno di voi comandando... ai nominati Turineto di Castiglione e Martino, figlio del fu Perroto Tintore, gestori e governatori del Ponte di Po, incarico e autorizzo... per l’osservanza di dette nostre divisione e regolazione dell’acqua in certo e breve termine... di porre certe grosse e lunghe pietre marmoree e fissare tanto presso il cantone di San Dalmazzo quanto presso il cantone dei Beccuti e altrove, se e dove sarà ritenuto opportuno.
E anche restringendo ed ampliando le misure delle pietre di detta bealera o roggia nei detti cantoni e altrove ove come sarà necessario su consiglio e discrezione... del padre signor Vescovo torinese nostro fratello, e vostro. Così ed in tal modo siano poste e allocate le dette pietre e la detta roggia sia sistemata in modo che l'acqua discorrente per detta città scorra attraverso e sopra le stesse pietre e attraverso le rogge predette, si divida e dispensi esattamente e secondo la predetta nostra disposizione... e secondo e come meglio e più utilmente sembrerà al detto signor Vescovo, a voi, e ai governatori sopraddetti.
E così... le integrali e singole disposizioni soprascritte con apposizione delle pene abbiamo incaricato di stabilire e di ordinare alla Maggior Credenza della nostra Città... a perpetua ferma disposizione. Vogliamo inoltre e disponiamo che coloro i quali hanno diritto di derivare e condurre detta acqua ai propri prati di pagare le spese che occorreranno per la predetta circostanza, e che a coloro che non sono autorizzati sia inflitta la pena.
Dato nel nostro castello di Torino, con apposizione del nostro sigillo …nell’anno del Signore Millesimo trecentesimo cinquantesimo terzo, sesta indizione nel ventisettesimo giorno del mese di novembre.
ASCT, CS 1884
La distribuzione delle acque provenienti dal boccaglio della Porta Segusina appare semplice e razionale, secondo lo schema del 50%—25% —25%. Metà del flusso è destinato alla roggia principale, che percorre l’antico decumano — la via maestra della città medievale — fino alla Porta Fibellona. La parte restante è distribuita in modo uguale, ossia per un quarto del totale, lungo le strade parallele, metà alla destra e metà alla sinistra dell’asse centrale. La ripartizione ha inizio al cantone di San Dalmazzo e prosegue negli altri cantoni attraverso rudimentali partitori posti all’imbocco delle singole vie, che convogliano i flussi d’acqua mediante semplici pietre disposte a mo’ di paratoie. In accordo con la livellazione delle strade cittadine, il deflusso avviene a sud attraverso i cunicoli delle Porte Nuova e Marmorea, e a nord attraverso quelli delle Porte Pusterla, di San Michele e del Palazzo, ossia la Porta Palatina.
Il documento offre anche altri elementi di interesse. Innanzitutto, conferma l’esistenza del sistema idraulico cittadino già prima della metà del XIV secolo — e forse da tempo considerevole, come suggeriscono i ripetuti riferimenti a consuetudini pregresse — nonché la ripartizione delle acque al cantone di San Dalmazzo, entrambi eventi talvolta erroneamente attribuiti a epoche successive.
Esso delinea anche il quadro delle competenze e delle responsabilità in materia idraulica. All’epoca, gli organi di governo torinesi erano ormai sottoposti all’autorità signorile. Il disposto nasce per volontà del Principe d’Acaia, che si rivolge a funzionari di sua nomina come il Vicario e il Giudice. La realizzazione delle opere è delegata ai Governatori del ponte di Po, Turineto di Castiglione e Martino, figlio del fu Perroto Tintore, anch’essi nominati dal Sovrano. La supervisione dei lavori è demandata al vescovo di Torino, cugino del Principe, affiancato dai governatori dei ponti per la definizione degli aspetti tecnici e operativi. Le funzioni della Città si limitano ad ambiti consultivi ed esecutivi, esercitati attraverso i probi viri – uomini privi di interessi personali nelle controversie, consultati dal Principe – e mediante la Maggior Credenza, incaricata di recepire le disposizioni, curarne l’attuazione e assicurare che chi aveva diritto di derivare e condurre l’acqua verso i propri prati contribuisse alle spese per l’esecuzione del piano, applicando sanzioni a chi ne fosse privo di titolo.

Fig. 10.2 – In città l’acqua percorreva le strade orientate in direzione est-ovest, parallele alla via Maestra, che univa le porte Segusina e Fibellona. Il reticolo, sebbene derivato da disegno seicentesco, riproduce con buona approssimazione il quadro medievale. Per facilitarne la lettura, sono indicati i nomi attuali delle strade, affiancati, quando possibile, da quelli originali riportati nel disegno.

Fig. 10.1 — La carta di Torino di Joan Carracha (1572) offre una visione semplificata del sistema idrico urbano, ridotto a due soli assi: la Doragrossa, lungo l’antico Decumanus Maximus (attuale via Garibaldi), e una Doiretta minore che percorre via Bertola. La mappa mostra con chiarezza il punto di ripartizione delle acque, in prossimità della chiesa e del convento di S. Dal-mazzo (oggi all’angolo tra via Gari-baldi e via delle Orfane). L’acqua en-trava in città dal boccaglio presso la torre nord di Porta Segusina e attra-versava diagonalmente il carignone.
Le Patenti del duca Ludovico di Savoia del 24 aprile 1454
Con le Patenti del 24 aprile 1454 il duca di Savoia Ludovico I riconosce alla Città e ai cittadini di Torino la facoltà di aprire nuove canalizzazioni e di ampliarne altre. (a) In particolare, concede piena licenza di costruire due nuove bealere: «da prendere ed estrarre l’una dal nostro fiume Dora, tanto sopra quanto sotto il castello di Alpignano, come ai nostri sudditi e al Comune sembrerà e piacerà; l’altra dal fiume Stura o dalla Ceronda, della larghezza ritenuta opportuna dagli stessi torinesi». Le bealere potranno attraversare qualunque territorio e proprietà, senza che alcuno — persona, comunità o ente — possa opporsi, verso, attraverso e dentro la città di Torino, nonché all’esterno di essa, con libero decorso delle acque, restando il solo obbligo di risarcire i danni arrecati. Il duca concede inoltre l’ampliamento delle bealere di Grugliasco e di Druento, considerata «la massima utilità» che i torinesi ne potranno trarre, «senza incomodo e danno» per quelle Comunità.
Nonostante la genericità dei vincoli — limitati alla sola indicazione di una presa a monte o a valle del castello di Alpignano — la derivazione estratta dalla Dora Riparia sembra corrispondere alla bealera Putea-Canale, scavata attorno al 1456, sebbene con presa nei confini di Pianezza. Meno fondata appare invece la rivendicazione delle Patenti del 1454 quali atti fondativi della bealera Cossola, avanzata dal consorzio di gestione della stessa.
L’individuazione della bealera — o delle bealere — da derivare dalla Stura di Lanzo solleva invece qualche perplessità. Alla concessione di una nuova bealera «da prendere dal fiume Stura (o Ceronda)» il documento sembra affiancare l’autorizzazione «di ampliare la bealera di Druento e, della stessa bealera, il bocchetto che è estratto dal fiume nostro Stura (o Ceronda), alla larghezza di un trabucco al fondo». Il duca dichiara infatti di essere «pienamente informato che la bealera di Druento viene condotta per gran parte lungo un antico alveo, chiamato la Roija, ovvero bealera di Torino», lungo il quale «la bealera che era chiamata bealera di Torino era condotta dal fiume stesso di Stura ai confini di Torino». Il riferimento alternato alla Stura o alla Ceronda è coerente con la confluenza dei due corsi d’acqua nell’area presunta di presa, ma non implica un’identificazione formale dei due idronimi, che il testo delle Patenti evita deliberatamente. Resta quindi aperta la questione se l’operazione consista nell’ampliare una bealera già esistente — quella detta di Druento — ovvero nel rifunzionalizzare un antico alveo, o ancora nel dare forma a un’opera sostanzialmente nuova. Anche le letture successive di questo passo non concordano e non possono essere considerate dirimenti. (b)
L’interpretazione di questa parte del documento è complessa. In seguito alla supplica della Comunità e degli uomini di Druento, il 20 maggio 1451 il Consiglio ducale concedeva loro di estrarre una bealera dalla Stura di Lanzo nei pressi di Balangero. Sebbene i lavori fossero subito iniziati, la lunghezza inusuale (c) e i contenziosi derivanti dallo attraversamento di numerose proprietà ritardarono l’esecuzione, tanto che l’opera fu completata solo circa settant’anni più tardi. L’ampliamento concesso appare quindi singolare, anche se il duca non poteva certamente sapere delle future difficoltà. Inoltre, la bealera tornava a confluire nella Stura presso Altessano, senza raggiungere — se non forse in misura marginale — il territorio torinese. (d)
Il punto più critico delle Patenti è però costituito dall’assunto secondo cui la bealera di Druento sarebbe stata in gran parte ricondotta lungo un antico alveo, detto la Roija o bealera di Torino, attraverso il quale una precedente derivazione avrebbe condotto le acque della Stura di Lanzo fino ai confini cittadini. Di tale infrastruttura, tuttavia, non si possiedono altre attestazioni o riscontri documentari indipendenti, né anteriori né successivi, che ne confermino l’effettiva esistenza o il percorso. Più in generale, pur tenendo conto dei limiti — innanzitutto cartografici — della documentazione disponibile, non si hanno notizie di canalizzazioni derivate dalla Stura con caratteristiche tali da poter essere, già in età medievale o immediatamente dopo, definite “bealera di Torino”. Tale idronimo compare infatti attestato solo a partire dal XVIII secolo, riferito al canale che dal molino del Martinetto raggiungeva la città.
Le ragioni dichiarate del progetto sono innanzitutto di carattere sanitario, come esplicitato dove afferma che la città «molto più salubre diventerà e in essa l’aria migliore sarà», secondo quanto riferito da medici ed esperti, con benefici per l’intera città e per il duca stesso, quando vi dimorava. Tuttavia è certo che, in epoche precedenti, le acque della Dora Riparia — e non della Stura — scorrevano nelle strade della città convogliate dalla bealera Colleasca: una circostanza che nel 1454 non poteva essere ignorata e che rende pertanto questo passaggio difficilmente spiegabile, se non in termini non operativi, bensì programmatici. Deve essere infine sottolineato che, sebbene Ludovico dichiari piena fiducia nella validità e fattibilità dell’impresa («...tenuto conto anche come ci è stata trasmessa una relazione degna di fede...») il progetto appare molto ambizioso e non privo di ostacoli tecnici dovuti sia alla lunghezza e alla livellazione dell’alveo, sia soprattutto all’attraversamento della Dora Riparia, inevitabile per portare le acque della Stura nell’abitato.
Non solleva invece dubbi l’allargamento della bealera di Grugliasco «per una misura pari a quella che essa ha al presente», vale a dire il raddoppio della larghezza di un’opera aperta nel 1416, salvo che anche in questo caso la motivazione viene ricondotta alle ragioni “sanitarie” già discusse.
In definitiva, il documento presenta un carattere prevalentemente permissivo, poiché autorizza interventi possibili e ne indica finalità generali senza prescriverne in modo vincolante la realizzazione. Le contraddizioni che emergono restano difficili da conciliare, in quanto mettono in tensione una realtà idraulica e territoriale che gli estensori del testo non potevano ignorare con una ricostruzione effettuata a distanza di secoli sulla base delle fonti disponibili. Tuttavia, tale divario è spiegabile, almeno in parte, alla luce della natura delle Patenti, da intendersi come un atto di legittimazione aperto, destinato a consentire e coprire iniziative future, più che come la descrizione puntuale di un programma idraulico compiutamente realizzato.
Note ____________________________
(a) Cfr. ASCT, CS 1912 e CS 1913, AST Sez. Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Feudalità, Articolo 766-Atti di visita e titoli riguardanti acque, bealere, mulini e canali, Paragrafo 2-Titoli riguardanti le derivazioni d'acqua dalla Dora, MAZZO 2. - Titoli della Città di Torino relativi ai diritti sulle acque scorrenti nel suo territorio.
(b) Ad esempio, Filiberto Pingone riferisce che «Ludovico di Savoia concesse ai Torinesi la facoltà di derivare due alvei dalla Dora, uno da condurre attraverso la città e l’altro all’esterno di essa, nonché di riprendere un antico alveo dal fiume Stura presso Druento, conducendolo fino alla città per l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione dei campi». (Cfr. Filiberto Pingone, Augusta Taurinorum, Torino, 1577, p. 64). Il passo, dipendente dal testo delle Patenti, riflette una delle possibili letture del documento, senza apportare elementi autonomi.
(c) La lunghezza di questa canalizzazione — che esiste ed è tuttora attiva — supera i 20 km.
(d) Anche in questo caso, l’uso degli idronimi non aiuta a chiarire il quadro: la denominazione di bealera di Druento risulta infatti applicata in epoche successive anche ad altri canali (quali la bealera Barola e la bealera nuova di Lucento), suggerendo che il nome non designasse necessariamente, in modo stabile, un singolo tracciato. Non vi sono tuttavia elementi per affermare che tale uso fosse già consolidato in età medievale, o comunque al tempo dell'emanazione delle Patenti.

Online dal 25-09-2025
.jpg)